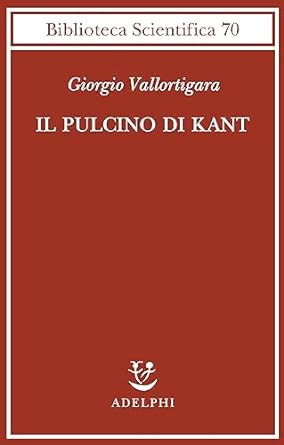MARCO VANNINI, SULLA RELIGIONE VERA. RILEGGERE AGOSTINO – LINDAU, TORINO
Il filosofo Marco Vannini (San Piero a Sieve, 1948) ha curato la traduzione italiana di tutte le opere, tedesche e latine, di Meister Eckhart, nonché di altri mistici antichi, medievali e moderni, dedicando loro numerosi studi. Autore di un’edizione bilingue del De vera religione di Agostino (2012) e di un Invito al pensiero di sant’Agostino (2014), nella sua ultima pubblicazione edita da Lindau si occupa ancora del Padre della Chiesa di Tagaste, con un volume intitolato Sulla religione vera. Rileggere Agostino, rielaborazione de La religione della ragione, uscito da Bruno Mondadori nel 2007.
Due sono le tesi fondamentali di questo nuovo saggio: che la Verità risieda all’interno dell’animo umano e che la fede cristiana coincida con la filosofia. Esaminiamo quindi questi concetti-base del volume, così come Vannini va analizzandoli nel corso delle pagine. Nell’estesa introduzione, l’autore stigmatizza il relativismo contemporaneo che induce le persone a crearsi delle credenze, sia in ambito religioso che in quello filosofico, sulla base di inclinazioni, valori e bisogni personali, avendo a progetto di vita esclusivamente la ricerca di una aleatoria felicità individuale, come viene suggerito da un diffuso ed effimero psicologismo, che non riconosce altre realtà se non il raggiungimento del benessere fisico e mentale della persona. Da questa rincorsa alla soddisfazione materiale derivano non solo le inquietudini e le fragilità che caratterizzano la società contemporanea (nonostante il proliferare di terapie, addestramenti e dottrine di ogni tipo), ma anche “lo svilimento del cristianesimo verso un banale umanesimo e filantropismo, con la perdita progressiva dell’elemento suo proprio di rinascita nello spirito”.
Parlare nel contesto attuale di “religione vera” e di “filosofia vera”, può richiamare negativamente un’idea di fondamentalismo, di fideismo acritico e intollerante. In realtà religione e filosofia sono attività rivolte allo stesso fine, cioè alla saggezza e conoscenza di sé, che esige una radicale conversione per la ricerca del Bene, da perseguire attraverso il rientro in sé stessi, nel distacco da ciò che è accidentale e molteplice, da ogni elemento legato al tempo e allo spazio, dalla dittatura del corpo e dalle esigenze esteriori imposte dalle mode sociali. Il raggiungimento della verità non dipende dall’obbedienza ai testi sacri e alle autorità ecclesiali, da liturgie e cerimonie formali, ma si ottiene con la rimozione dell’inessenziale, per recuperare la luce interiore, quella dello spirito, dell’Uno e dell’Eterno, seguendo la via che l’insegnamento neoplatonico, attraverso Agostino, ha introdotto nel mondo cristiano.
Il primo capitolo del volume, dedicato alla filosofia antica, presenta un denso excursus sul pensiero classico. Tutti i filosofi greci, dai Presocratici fino ai Neoplatonici, si proposero di indicare, più che un sistema teorico, un modello e un indirizzo di vita in grado di condurre alla saggezza, alla serenità, alla contemplazione dell’Eterno, impegnando l’intera esistenza in vista di una sua trasformazione. A partire dalle dottrine di purificazione di Pitagora, attraverso il severo richiamo socratico alla giustizia posta al di sopra di ogni contingenza storico-politica, si arriva a Platone che insegnava come filosofare fosse “esercitarsi a morire”, lontano da tutti i legami materiali e concettuali, per ascendere gradatamente dalla bellezza sensibile a quella intelligibile, fino alla contemplazione della luce immutabile che è il Bene in sé. Anche tutte le scuole post-aristoteliche ellenistiche e romane (epicurea, stoica, cinica, scettica, neoplatonica) declinarono in modi diversi la stessa esperienza: attraverso la pratica di esercizi spirituali e l’uso della temperanza e della continenza, si procede da una visione delle cose dominata dalle passioni individuali a una rappresentazione del mondo governata dall’universalità e dall’oggettività del pensiero. Plotino ammoniva “distàccati da tutto” (Áphele pánta) per approfondire la conoscenza interiore, che conduce alla comunione con tutti gli uomini e le cose, e attraverso l’ékstasis, all’Uno, fine ultimo, luce e perfezione.
Il secondo capitolo del volume esplora il concetto di religione nel suo duplice aspetto di mitologia e di mistica, da quando essa si confondeva con la magia e la superstizione, e veniva praticata per ricavarne benefici individuali o collettivi, fino a quando il cristianesimo dei primi secoli entrò in contatto con il mondo greco, assorbendone il concetto di filosofia intesa come meditazione, insegnamento e guida per l’esistenza. Di questo traghettamento dalla credulità popolare a un concetto più spirituale del divino fu artefice soprattutto Agostino (Tagaste, 354-Ippona, 430), negli anni giovanili profondamente influenzato dal pensiero scettico e neoplatonico che esortava a cercare nella propria interiorità la luce eterna di Dio. Nel testo De vera religione (389-391) scriveva infatti: “non uscire fuori di te, rientra in te stesso, la verità abita nel profondo dell’uomo”, ricalcando una terminologia decisamente plotiniana. In età più matura e rivestendo l’incarico di vescovo, Agostino privilegiò un’interpretazione della Bibbia e delle lettere di Paolo più fedelmente vicina alle proposizioni teologiche del cattolicesimo a lui contemporaneo, ergendosi ad accanito difensore della Scrittura. Non considerò più la religione subalterna alla filosofia, ma essa stessa Logos, essa stessa unica e vera filosofia. L’esperienza neoplatonica dell’identità spirituale uomo-Dio-cosmo, animata dal desiderio di unione mistica con il divino, venne così abbandonata in favore della visione biblica dell’alterità di Dio, secondo un’interpretazione puramente scientifico-teologica della Parola che ridusse il cristianesimo a dogmatismo, formalità rituali e pura esegesi dei testi sacri.
La critica di Marco Vannini alla pretesa storicità della Bibbia è implacabile, poiché ritiene i fatti in essa raccontati (a partire dalla Creazione) suggestive creazioni letterarie, la cui attendibilità è inficiata da incongruenze e contraddizioni, evidenziate in rigorosi studi epistemologici degli ultimi due secoli. L’Antico e il Nuovo Testamento sono il risultato di rielaborazioni create a partire dal VII secolo a.C. e protrattesi fino al II d.C, per imporre politicamene l’unicità di un dio, di un culto, e di un unico centro religioso, attraverso regole comportamentali, leggi sociali e fantasie apocalittiche che hanno finito per nutrire intolleranza e fanatismo, mettendo in secondo piano l’idea di spiritualità, di unione con il divino, di immortalità dell’anima. Le tesi coraggiose dell’autore, che molti esegeti ortodossi non esiterebbero a definire eretiche (un plauso alle edizioni di ispirazione cattolica Lindau che hanno pubblicato il volume), sottolineano come l’allontanamento dal pensiero filosofico greco abbia relegato il cristianesimo in una concezione materialistica e utilitaristica, immiserente anziché liberante.
Sarà il misticismo speculativo medievale a recuperare la preziosa eredità del pensiero classico, e appunto al misticismo Vannini dedica l’appassionata ultima parte del libro. Massimo esperto italiano degli scritti di Meister Eckhart, qui lo studioso toscano inizia invece la sua esposizione presentando la figura del castigliano San Giovanni della Croce (1542-1592), anch’egli profondamente debitore del neoplatonismo: solo dopo aver sperimentato la “notte oscura” del nulla, del vuoto, l’anima può risalire alla luce, connaturandosi a Dio che non è più oggetto di conoscenza, alterità alienante, idolo antropomorfico, ma puro spirito, unica identità con l’anima umana che si divinizza, diventando Dio e partecipando della sua luce. Tale percorso di salvezza per il carmelitano spagnolo può attuarsi solo con la rinuncia e il distacco da tutto, esattamente come insegnava Plotino: “la sostanza dell’anima, unita a Dio, assorbita in lui, è Dio per partecipazione di Dio”.
Nella storia del cristianesimo i mistici, accusati di sopprimere la distinzione tra uomo e Dio, furono emarginati, poco compresi e guardati con sospetto: eppure eliminando l’opposizione tra soprannaturale e naturale, tra divino e umano, hanno insegnato una verità riconosciuta anche dalle religioni orientali e dalla filosofia, cioè l’identità del Tutto, e dunque del divino nel cosmo e in tutti gli esseri, che tutti esistono in Dio. Lontana dal panteismo che appiattisce la trascendenza divina sulla natura, la religione vera supera l’alterità di Dio e il dualismo soggetto-oggetto, unificando tutte le creature in un solo essere, spiritualmente eterno, scevro dai vincoli della materia e della carne nell’unità relazionale con il Tutto. Libera dalla volontà, libera dall’attaccamento, e dunque libera dall’opinione, la luce dell’intelligenza illumina il Tutto. La mistica ha mantenuto viva questa verità, con l’esperienza di un modello di vita filosofico, del distacco, della grazia, della libertà, opposto alla vita nella servitù, nella forza, nella volontà e nel desiderio. Non occorrono perciò rivelazioni o visioni particolari, dogmi o encicliche, perché è il quotidiano, il qui e l’ora, con le cose presenti di fronte a noi, a costituire il divino così come si mostra al nostro sguardo e al nostro amore.
© Riproduzione riservata «Gli Stati Generali», 20 novembre 2023