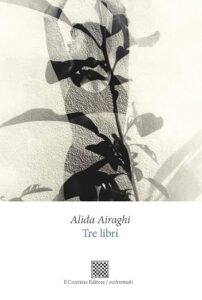CLAUDIO DAMIANI, POESIE – FAZI, ROMA 2010
Presso l’editore Fazi è uscito un volume antologico del poeta romano Claudio Damiani, che raccoglie testi pubblicati dal 1987 ad oggi. Nella sua ammirata ed affettuosa prefazione, Marco Lodoli afferma che in questi versi, classici e cristiani insieme, l’autore «sogna un’eternità che comprenda il prima e il poi, l’ora in cui ancora non eravamo e quella in cui forse ci ritroveremo senza più dolore…» E in effetti, la poesia di Damiani ben si può definire classica, nutrita di «distesa purezza», come suggerisce il prefatore. Soprattutto nella prima parte del volume, scandita in elegie ed odi, e tanto immersa nella stupefatta contemplazione di una natura innocente ed eterna, i nomi di riferimento che più vengono in mente sono quelli di Virgilio (Le Bucoliche e Le Georgiche), con i suoi pastori, le stalle, i vitellini, i fiumi e i giardini. Ma anche Catullo e Ovidio non sono lontani dalla sensibilità del poeta. E poi si riconosce in lui una voce limpida e gentile che si rifà a una collaudata tradizione novecentesca: dai crepuscolari a Saba, a un Penna innamorato dei colori («il cielo è azzurro azzurro»). Molti vocaboli desueti evidenziano una ricercatezza e ed eleganza quasi ottocentesca, che tuttavia non disturba, ma bene si accompagna al tono pacato e intenerito dei versi (opre, guata, mira, fere, verno, lene..), alla loro esibita antimodernità: «non vorrei sentire il suono del calesse / del lattaio che viene dalla lontana strada». Il dialogo con la natura è ininterrotto e riconoscente: essa mai appare minacciosa, ma sempre innocua, pulita, rasserenante. La vegetazione viene narrata con attenta precisione: i nomi che tornano sono quelli degli eucalipti, del noce, della gramigna, della lonicera, e del mirto che nella sua crescita imprevista e sovrabbondante ricopre con generosità una tomba abbandonata. Anche gli affetti umani sono indagati con tenerezza e gratitudine: quelli per la moglie, per i figli piccoli e da proteggere con amore, per gli alunni con «la loro libera gioia / come una cascata luminosa», o per gli amici precocemente scomparsi. E la morte è presente ovunque, ma priva di drammaticità o angoscia: quasi come una continuazione della vita in un’eternità che tutto abbraccia e consola, senza una reale distinzione tra l’esserci e il non esserci più. Una visione cristiana, forse, perché il poeta prega, e crede nella bontà del tutto; ma se nel cristianesimo esiste anche il peccato, la colpa, la condanna, Damiani non se ne fa interprete: la sua è una visione irenica, riappacificata, dell’esistente, più vicina -come giustamente suggerisce Lodoli – alla serenità del taoismo che alla drammaticità della croce cattolica. C’è in ogni poesia un invito all’attesa, alla sospensione, al fiducioso abbandono in una forza cosmica positiva e riparatrice. L’uomo appartiene alla natura, come le foglie, come le formiche, e vive la caducità del suo passaggio mortale con tranquilla accettazione e religiosa obbedienza alle leggi del creato: «restiamo ancora un po’ in quieta attesa / mantenendo l’animo vigile, e quieto, / ringraziando il cielo per ogni più piccolo dono, / per ogni istante di vita ancora uno davanti all’altro»» , «che bello che non siamo eterni, / che non siamo diversi / da nessun altro che è vissuto e che è morto, / che è entrato nella morte calmo / come su un sentiero che prima sembrava difficile, erto / e poi, invece, era piano», «e quando moriremo questo paradiso / che noi abbiamo trovato, che era per strada / sotto gli occhi di tutti, / lo porteremo con noi sotto terra / e anche sotto terra continuerà a brillare», «Morire è come nascere / qualcosa che non è che dobbiamo fare noi».
Essere felici di tutto, e del poco; sentire la solidarietà e l’uguaglianza con ciò che ci circonda, sia esso vivente o inanimato come le montagne; non fermarsi a osservare le brutture: «vorrei montare sulla mia biciclettina / n.14 e pedalare tra le case, / e se le case crollano / non le vorrei vedere / vorrei voltarmi dall’altra parte / e non vedere». Salvare la dolcezza: «capisce che solo la gentilezza c’è data / e che la vita vale viverla / per essere gentili». E il compito del poeta sembra essere lo stesso di quello di un pittore, magari di una paesaggista cinese del 1700, che nei suoi acquerelli delicati riproduce la bellezza tranquilla che lo circonda: «Vorrei semplicemente descrivere / quello che vedo, non altro / non mi interessa inventare / mi piace camminare / e mi piace guardare». Ecco, Damiani è un poeta di immagini: un antico, mite, indulgente, validissimo poeta contemporaneo.
«Farapoesia», 8 febbraio 2011