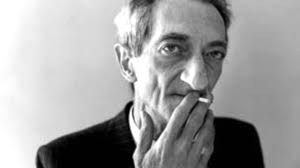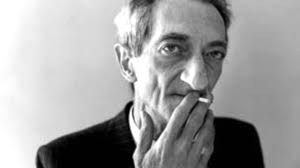
EDOARDO SANGUINETI: DALL’OPPOSIZIONE AL COMPROMESSO – 1985
ma qui ho scoperto che / non ho più età: che sono morto molte volte, almeno: // e che adesso, che potrei dire / tutto, proprio, non essendo più vivo davvero, non ho più niente da dire, ecco:
scriveva Sanguineti, nel ’77, a chiusura del suo Postkarten (PK 67), evidenziando (secondo la nota in copertina) «un’aspirazione al silenzio…che indica una pausa, forse la necessità…di fare il punto». Quel silenzio è rimasto un pio desiderio, durato poco più di due anni, se Sanguineti ha pubblicato già nell’80 Stracciafoglio (STR): un libro doppio, composto da una prima sezione di 47 poesie, che continuano idealmente il percorso di Postkarten e di Reisebilder (R), e da una seconda serie di testi d’occasione scritti tra il ’57 e il ’79. Quest’ultima parte (Fuori Catalogo) si presenta come una miscellanea di interventi tanto disarticolati da giustificarsi soprattutto per il loro valore documentario: si passa infatti dalle polemiche contro una certa cultura progressista ma non materialistica (i cui simboli sono Moravia e Pasolini), agli acrostici-omaggio ancorati a uno sperimentalismo ormai di maniera, per arrivare alle più recenti testimonianze civili elettoralistiche scritte nel nome del PCI (Primo Maggio, Federbraccianti, 16 giugno 1944, Vota comunista, Ballata per gli anni 80).
Il Sanguineti messo in luce da questi componimenti (sparsi, ricordiamolo, lungo un ventennio) è quello meno catalogabile stilisticamente, meno omogeneo nei contenuti, e che perciò più sfugge a una valutazione critica che voglia tentare un pedinamento del poeta nella sua ultima parabola, e una sovrapposizione dell’autore (che nello scorso decennio ci ha fornito indicazioni ibride e fuorvianti) con il politico invece sempre lucido nei piani e conseguente negli sbocchi. Pertanto rinuncio a soffermarmi anche sulle due poesie più emblematiche di questa seconda sezione, quelle dedicate a Pasolini (Una polemica in prosa, del ’57, e Le ceneri di Pasolini, del ’79), perché la lettura derivante da un puro e semplice accostamento dei due testi potrebbe solo riscontrare, in maniera anche riduttiva e ovvia, un interessato recupero e riadattamento di Pasolini in una prospettiva nostalgica e conservatrice. Mi importa invece discutere specificamente la prima parte del volume, che dà il titolo alla raccolta, per rilevare come essa si inserisca fedelmente nel solco già tracciato dagli ultimi due libri, ribadendo scelte linguistiche e ideologiche che segnano un confine netto dalle prime posizioni sanguinetiane, fino a fare della sua poesia odierna «un’arte da museo» (1), e del suo autore quello che egli desidera essere: «un professore, un deputato, un vetero» (STR. 47).
Dai primi testi poetici a oggi, Sanguineti è venuto man mano delimitando e circoscrivendo il ruolo e la funzione della ricerca e della sperimentazione linguistica a strumento di indagine letteraria, a tirocinio e banco di prova delle proprie capacità espressive (2). Era evidente che dopo Laborintus e Erotopaegnia, Sanguineti non potesse spingersi oltre sulla strada della disgregazione linguistica, della dissacrazione ironica, della desublimizzazione eversiva, pena l’arrivo al silenzio, all’autocensura. Quindi, s’imponevano una revisione, una sterzata, che effettivamente ci furono, in parte già nel Purgatorio de l’Inferno (1960-1963), ma poi soprattutto in Reisebilder e Postkarten: il linguaggio veniva rivalutato nella sua positività, come strumento di comunicazione, indipendentemente dagli inevitabili abusi interpretativi e dai fraintendimenti più o meno consci. Nell’impossibilità e inutilità della provocazione, esso poteva e doveva servire all’utente-soggetto come strumento di analisi interiore e ponte verso l’esterno, verso i lettori.
Di conseguenza, il nuovo linguaggio di questa nuova poesia sanguinetiana perde il suo connotato più direttamente ideologico (linguaggio come espressione e creazione di storia e ideologia, linguaggio riconosciuto come mistificazione e usato in quanto arma disgregatrice contro l’ordine borghese), in qualche modo si neutralizza, e, incaricandosi non tanto di scandalizzare quanto di far partecipare, non ha più come oggetto gli altri (=provocazione), bensì l’io del poeta (=indagine psicologica). Diventa coscientemente lingua letteraria, che parte dai crepuscolari, attraversa gli ermetici per approdare a un discorsivismo di impianto realistico. In questo ambito, anche la memoria è riscoperta con una sua specifica funzione, quella appunto letteraria: essa viene presa di nuovo in considerazione come forma di conoscenza (proprio nel senso “greco”); la poesia deve essere memorizzata (imparata a memoria) per assicurarsi una circolazione e quindi una fruizione più ampia (3). Poesia come parto di memoria, vaglio-travaglio di tradizioni concorrenti. E poesia come memorabilità. Da qui la scoperta “tecnica” del ritmo, della facilità e della cantabilità, delle rime, della narrazione. In una parola, del carattere orale della poesia.
Ma le più importanti indicazioni estetiche dell’ultimo Sanguineti sono state espresse in direzione del contenutismo e del realismo, e se in Stracciafoglio non troviamo le concrete indicazioni di stile e le esplicitazioni di poetica che avevano costituito la chiave di lettura di Postkarten, anche qui c’è però un costante adeguarsi alle scelte linguistiche inaugurate (e propugnate, difese ideologicamente)
nel libro precedente. Come si deve scrivere una poesia, Sanguineti l’aveva già spiegato in PK 49: alcuni versi possono offrirci un particolare orientamento su come decodificare la sua ultima produzione. Alla base del nuovo realismo sanguinetiano sta un’attenzione per il fatto minuto, quotidiano; non la storia, bensì la cronaca, il particolare, l’umile, tornano a essere argomenti eletti, ingredienti basilari per una poesia che si vuole domestica (ma che spesso finisce per risultare addomesticata):
PK 49
per preparare una poesia si prende “un piccolo fatto vero” (possibilmente / fresco di giornata):
La poesia va “preparata”, in spregio a qualsiasi mistificazione sull’ispirazione, sull’occasione poetica, sull’attitudine interna: scrivere versi è un’operazione intellettuale, un sapiente collage razionale (4).
conviene curare / spazio e tempo: una data precisa, un luogo scrupolosamente definito sono gli ingredienti / più desiderabili, nel caso: idem per i personaggi, da designarsi rispettando l’anagrafe; / da identificarsi mediante tratti obiettivamente riconoscibili):
Ritorniamo ai topoi aristotelici: spazio, tempo, azione, «precisi», «scrupolosamente definiti», che «conviene curare»: dati di prima mano, avvenimenti che presuppongono la partecipazione o almeno la presenza del poeta. Eventi autobiografici, amici o conoscenti da segnalare scopertamente, in modo tale che siano facilmente identificabili e collocabili nel loro ruolo. A questi suggerimenti, Sanguineti si attiene anche nei versi di Stracciafoglio, sottolineandoli in particolare in:
STR 46
comunico le coordinate necessarie: torno da Como, è il 26 / settembre, sono le 21,37, ho chiesto il conto al ristorante, prenderò il rapido / delle 21,50
E ovunque, nomi e cognomi di protagonisti della cultura nazionale e internazionale, interni ed esterni europei (5), mesi-giorni-ore precisamente segnalati. Ma bastano luoghi, date, personaggi, fatti oggettivati nel loro concreto “essere accaduti” per poter parlare di realismo? E secondo la nota distinzione lukacsiana, a quale realismo potrebbe far riferimento Sanguineti, a quello socialista o a quello critico (oppure si deve postulare l’esistenza di una terza via anche al realismo?)
Sembra infatti pretestuoso (e presuntuoso) definire realista una poesia in cui attori e ambienti non hanno altra funzione, altra connotazione (non parliamo di collocazione di classe!) se non quella di fare da scenario all’individuo poeta. Su sfondi evanescenti si agitano personaggi-larve, evocati come spettri da un buio in cui ripiombano nello spazio di due versi, in una poesia diaristica più vicina al diario di Montale che a quello di Gozzano, dove è più urgente l’angoscia che l’ironia.
L’oggetto di questa poetica è sempre l’io sanguinetiano, ma non tanto come ricerca o viaggio interiore, quanto proprio come esibizione di sé, tentativo di coinvolgere chi legge nel ruolo di confessore-assolutore. E’ legittimo allora parlare di autobiografismo per questi «monologhi esteriori» (STR 47) in cui l’intellettuale Sanguineti si esibisce, si sfodera, si osserva volteggiare (ironico e patetico, edulcorato e selvaggio) in ambienti eterogenei ma sempre accomunati da un’identica posizione medio/alta borghese, culturalmente à la page. Si potrebbe addirittura supporre nel poeta la volontà di ricostruirsi con i versi una biografia ideale, che non si limiti a un tradizionale e consolatorio “portrait of himself”, ma ambisca a una severità oggettiva e distaccata:
STR 5
il sugo, nel guardarsi, è sapersi guardare: (è l’oggettivazione: / che si ottiene): (è l’oggettivazione che si propone, ecc.):
STR 108, Cinque risposte
(e l’importante, sempre, è vivere in terza persona):
Ciò che si ricava da un’autorappresentazione del genere, che tende all’imparzialità nel ritrarre e all’impersonalità nei risultati, è l’immagine un po’ stereotipata (proprio perché voluta, costruita come un puzzle) dell’intellettuale che si dibatte tra angosce di degradazione fisica e incubi di tradimento o dispersione morale.
STR 26
eccomi qua, piazzato al caffè della stazione, ridotto così come mi vedo / (e come tu mi pensi, certo), a un involontario inventario di sbriciolate / gesticolazioni ossessionali, di male contenuti stralci di quotidiane psicopatologie / sublimali: ( e a un individuo): ( a un tipo):
STR 31
dove finisce il mio io, non lo so, io: ho coscienza, soltanto di un supplemento / di investimenti e di proiezioni nelle mie calze e cravatte, nelle mie chiavi / che ho in tasca, nelle mie valigie che ho in mano:
STR 14
nuoto nel vuoto, in stati d’ansia a strati, più o meno densi, fasciato / dal mio niente:
Come in Reisebilder e in Postkarten (6), anche in Stracciafoglio, se pure in misura inferiore, l’invecchiamento del corpo diventa ossessiva minaccia di dissoluzione, da cui Sanguineti si difende con un’ostentata scatologia liberatrice:
STR 45
di cerume / nelle mie orecchie, l’unghia incarnata, l’occhio di pernice, la cicatrice / nasale, e questo stesso ascesso dentario:
STR 9
per quel mio incubo di quelle mie corde, invece, che me le strappo via dalla mia gola, // vomitandomi laghetti di salive spesse (e diciamole, in breve, le mie corde vocali), / mi sono fatto le mie associazioni libere, alla mia prima siesta: // e il risultato / è che parlano in favore del marcio che mi morde dentro:
STR 10
e me lo sono poi sfogato, / tra schizzi e spruzzi, sopra un trono da lustrascarpe, un cesso da stazione, vero, da / antiquariato industriale, il mio intestino;// …mi pulivo il mio culo, finalmente:
Se a livello inconscio (si confrontino anche le STR 42 e 44) la fisicità rimane un nodo irrisolto, razionalmente e ideologicamente si vede in essa una possibile risposta positiva, un traguardo da raggiungere:
PK 35
(e ho concluso che il paradiso è chiavare nel sole, forse, pieni di Saint-Emilion):
STR 43
le più convinte benedizioni devono piovere sopra coloro, / certo, che legarono il proprio nome al piacere: gastronomi sottili che elaborarono / inaspettati intingoli succulenti, geniali suggeritori di estatiche posizioni erotiche / inedite:
Ma questa dissociazione tra ciò che la ragione sa (e vuole) e ciò che l’elemento irrazionale teme, esiste ed è difficilmente superabile, anche per quello che riguarda la sfera dell’etica e della politica. Anzi, proprio in questo campo Sanguineti patisce la divaricazione più sofferta tra speranza e conoscenza, utopia e compromesso o, in termini pasoliniani, cuore e viscere. Insomma, da una parte la coscienza che morde, dall’altra il cervello che finge.
STR 18
tra il pubblico e il privato, per capirci, patisco, ti confesso, di una gestibile / schizofrenia:
Infatti, se nel privato si trova a fare i conti con piccoli fallimenti quotidiani (come padre, come marito – cfr. STR 2, 83, 46, 47), con la noia di rapporti abitudinari o il tradimento di amicizie, nel pubblico l’infedeltà “all’idea” è vissuta con angoscia maggiore, proprio perché non investe solo la sfera affettiva. Perciò, se in alcune poesie Sanguineti sembra voler convincere se stesso della propria coerenza politica attraverso un rigido richiamo all’obbedienza e alla tradizione, e la sua posizione risulta essere quella – datata – dell’engagé organico e sentenziante (cfr. STR 20, 30, 34, 47), più spesso questa sicurezza adamantina si sfalda, rivelando il patetico simulacro di un “io” improbabile:
STR 41
sospetto che una falla possa aprirsi / sotto i miei piedi, nel mio tempo pieno: // mi sorveglio e mi invigilo (e mi / punisco, è chiaro), cercando nei miei giorni, vecchi e nuovi, l’indizio che mi svela:
STR 15
quello che credo, io lo vorrei volere:
STR 27
mi vivo sotto falso corpo, per potermi vivere ancora: e con un’idea di me / che a me nascondo: (e che nascondo a te, specialmente):
L’idea di un se stesso da nascondere potrebbe essere proprio la consapevolezza di un cedimento che non si vuole ammettere, la nostalgia per la durata e l’incrollabile fiducia negativa del passato: nostalgia di un’aggressiva disperazione che ha ceduto il posto a una composta attesa, e di una vivacità/vitalità cui è subentrato il tranquillo pessimismo odierno. C’era già in Postkarten una poesia che segnava in maniera illuminante questo passaggio dalla ribellione alla resa:
PK 26
c’ero una volta io, disperato e vivo: / e ho piegato / per sempre la mia testa sopra il tuo grembo, dentro la tua matrice: / mi basterebbero un paio di testimoni, per salvarmi, adesso: per garantirmi / secco e sgradevole come mi speravo, intrattabile come forse sono stato: (7)
Questo movimento involutivo, di arretramento dall’esterno verso l’interno, dalla proiezione nel futuro all’equilibrio nel presente, trova in Stracciafoglio una sua pseudo-giustificazione politica, di realistico adeguamento alla concretezza dell’ora storica, di matura accettazione del compromesso:
STR 7
e che se un poeta ci sta a fare un qualche cavolo di cose, per caso, di questi tempi / oscuri e vuoti, sarà un poeta spretato, in borghese: (e un borghese): (va bene, ma uno, / intanto, che ci dice che così stanno le cose come stanno):
STR 34
e tuttavia, liquidata l’utopia, / mi allontano a velocità fantastica, se non altro, da sirene, da mostri, da chimere:
STR 36
all’utopia ho rinunciato senza pena: / penso, semplicemente, oggi, con tanto sobrio realismo, che sopravvivere / in comune, con casa, cibo, abito, scuola, lavoro, pensione, ecc., qui, ormai, / sarà un’impresa disperata, per gente civile: (e che non c’è da chiedere di più, / molto, al mondo: e che questo, forse, sarà già tutta un’utopia, per noi):
Sembra un po’ un programma da poetica dei sacrifici, in accordo con Lama e Berlinguer: per cui la felicità sta tutta nell’accettare il presente, pur nella sua meschinità, e nell’accantonare l’illusione utopica:
STR 37
ho incominciato a capire il presente: (parlo per me, parlo di me): (ho incominciato / a goderne, a goderlo)…// ho incominciato a conoscere la felicità, davvero, la vera:
Politicamente, se tentiamo un traslato, è proprio un caso che il presente, adesso, in Italia, si identifichi con la DC, e l’utopia con il non-potere dell’opposizione che è rimasta? Probabilmente no, se Sanguineti, oltre a essere il poeta che scrive queste cose, è anche Deputato PCI.
STR 36
credo nel compromesso storico, nella via italiana / al socialismo, nella dittatura del proletariato (con le sue varie, e se vuoi anche / infinite incarnazioni storiche possibili, d’accordo): // e in Antonio Gramsci:
Eppure, in Stracciafoglio, non è tanto questo messaggio politico – lineare nello sviluppo e nelle finalità “pubbliche”, ma lacerante e schizoide nel privato – a creare sconcerto (tra l’altro, questo perpetuo interrogarsi, e fingersi risposte convincenti, e ancora non rassegnarsi alla finzione, e di nuovo cederle, può costituire la base per una preziosa autocritica), quanto il fatto che tale contrastato messaggio si affida a una poetica che invece non fa i conti con se stessa, e da circa un decennio si offre immutata e ripetitiva.
Da Reisebilder a Postkarten fino a Stracciafoglio, infatti, la poesia sanguinetiana si struttura non solo a livello sintattico e formale (ossessive insistenze sui pronomi, ripetizioni, incisi e inversioni; moduli discorsivi, plurilinguismo, citazioni, formule proverbiali o gnomiche), ma addirittura graficamente (stesura orizzontale sulla pagina, parentesi nelle parentesi, due punti), secondo schemi pressoché invariati. A questo «intollerabile tardo stile cacofonico» (STR 12), Sanguineti assegna il compito di rifondare il neo-contenutismo (8), recuperando la funzione comunicativa della poesia ma perdendo nello stesso tempo il suo carattere “critico”. Perché questo suo “far poesia”, lungi dal mettere e dal mettersi in crisi, appare ormai codificato, ritualizzato e, in quanto tale, prevedibile. Sanguineti si è bloccato in un impasse non tanto politico (abbiamo visto come la sua posizione coincida con quella del Partito Comunista, e proprio per questo non sia isolata e minoritaria), ma estetico.
Mentre in Laborintus la disgregazione e la nevroticità del testo rivelavano un indubbio progetto di eversione ideologica attraverso l’eversione linguistica, negli ultimi tre volumi una poesia carica di tradizioni letterarie torna a proporsi come divertissement, consolazione, confessione. E lo fa servendosi dei contenuti che abbiamo analizzato (qua un po’ di tenerezza maritale o paterna, là una spolveratina di cupio dissolvi, molte citazioni, qualche interno e qualche esterno europeo) e di una forma prosaico-saggistica sostanzialmente sempre uguale a se stessa. Con Stracciafoglio Sanguineti ha ribadito la sua conciliazione col mondo e con il linguaggio, si è riconfermato poeta morbido (cfr. PK 26) pronto all’indulgenza e all’auto-indulgenza, abissalmente distante dalla secchezza e sgradevolezza dei tempi del Gruppo 63. La scelta di non scandalizzare più la borghesia è stata giocata sui due fronti, quello politico e quello poetico: un patto stretto con gli uomini e con le parole:
STR 17
but men are men, l’ho imparato a mie spese: (in inglese): (come ho imparato / a rovesciarlo in positivo): (a mie spese, anche questo: questo rovesciamento: / l’umano rovesciarsi nell’umano): //…e ho scoperto la battuta / parallela: (ho scoperto che posso rovesciarmela, anche quella): / (se lavori con le parole); (se lavoro): adesso: but words are words: // (che è l’unica mia mossa):
Per cui, se gli uomini sono uomini – e ad essi bisogna adattare, costringendole, teorie e idee -, le parole sono parole, e anche in omaggio a esse Sanguineti ha accettato il compromesso.
NOTE
1) La definizione è dello stesso Sanguineti, riferita all’avanguardia: cfr. Ideologia e linguaggio. Milano 1978, pp. 65-66, e Una polemica in prosa, STR 63: «io spiegavo, a suo tempo, /…come io / tentassi di fare dell’avanguardia, / in quel libretto, un’arte da museo». È chiaro che qui non viene usata, tuttavia, nell’accezione sanguinetiana.
2) Questo uso strumentale dello sperimentalismo viene ammesso in Cinque Risposte (STR 108): «quando mi allontanai dal labirinto, ne compresi la forma: (quella forma, / così, l’ho compresa due volte: costruendo il labirinto, e allontanandomi: //…(e voglio dire, anche, che bisogna prendere e lasciare, nel tempo):»
3) Cfr. PK 49: «concludo che la poesia consiste, insomma, in questa specie di lavoro: mettere le parole come / in corsivo, e tra virgolette: e sforzarsi di farle memorabili, come tante battute argute / e brevi: che si stampino in testa, così, con qualche contorno di adeguati segnali / socializzati): (come sono gli a capo, le allitterazioni, e poniamo, le solite metafore): / (che vengono a significare, poi nell’insieme: / attento, o tu che leggi, e manda a mente):». Dove la raccomandazione “dantesca” implica un prioritario fine didattico della poesia: essa si deve far ricordare perché insegna qualcosa, il lettore deve memorizzarla per imparare, e il poeta torna a essere “maestro”. L’aveva già scritto Montale, Nel nostro tempo, Milano 1972, p.51: «Un’arte che distrugga la forma pretendendo di affinarla si preclude la sua seconda e maggior vita: quella della memoria e della circolazione spicciola».
4) La polemica di Sanguineti ha come obiettivo la poesia aristocratica, intrisa di se stessa, poesia “d’atmosfera” che oggi sembra tornare di moda tra i poeti “innamorati” della parola. PK 60: «raccomando ai miei posteri un giudizio distratto, per i poeti del mio tempo: / (perché fu il tempo, dicono, della distratta percezione): // è inutile pensare, adesso, / ai neostrutturalisti dannunziani (e a tutti gli “orecchini” che verranno, se verranno): / (come è inutile diagnosticarli, rigidi, questi sciamani di Lucifero, e le loro squisite / disperazioni, tra le fedi e le speranze dell’ultima spiaggia borghese, tra i lampi / ardenti dell’apologetica indiretta apocalittica):»
5) Il viaggio costituisce uno dei fili conduttori dalle poesie di Reisebilder in poi: viaggio inteso anche in senso metaforico come scoperta e rinuncia, come distrazione dall’impegno e ampliamento di confini, come stordimento e alternativa all’analisi cerebrale severa (viaggio come consolazione?).
6) PK 8: «perdere / la faccia ( e perdere la testa) è facile dunque; (ma è poi niente, / se pensi che mi porto ancora addosso i pollici, i capezzoli, i coglioni):»; PK 50: «il mio cervello / trema come marmellata marcia, moglie mia, figli miei: / (il mio cuore è nero, peso 51 chili: // ho messo la mia pelle / sopra i vostri bastoni:»; PK 51: «io ho deciso di ingrassarmi, ormai: / che mi sono visto il mio teschio nudo, dietro lo specchio del bagno:»; R 39: «questi cuscini che si spappolano, formicolano mostruosamente / dei miei capelli perduti: / ritornerò mezzo calvo, all’ombra dei limoni in fiore:»; e ancora R 40, R 45, PK 53, PK 38.
7) È forse il caso di ipotizzare, nei due attributi iniziali, un’eco della “disperata vitalità” pasoliniana, dove anche per Pasolini si trattava di una lotta utopica e perdente contro l’inerzia del buon senso comune.
8) Cfr. Purgatorio de l’ Inferno 5: «o quando dissi (all’altro): (al Cristallo, credo) che bisognava / (quel pomeriggio) fondarlo: (il neo-contenutismo): (viri duplices): ( e fu cosa / fatta):».
I libri di Sanguineti citati in questo studio sono:
Laborintus, Magenta, Varese 1956; Opus metricum, Rusconi e Paolanni, Milano 1960 (contiene Laborintus ed Erotopaegnia); Triperuno, Feltrinelli, Milano 1964 (contiene Opus metricum e Purgatorio de l’Inferno); Wirrwarr, Feltrinelli, Milano 1972 (contiene T.A.T. e Reisebilder); Postkarten, Feltrinelli, Milano 1978; Stracciafoglio, Feltrinelli, Milano 1980 (in appendice Fuori Catalogo, che raccoglie poesie d’occasione scritte tra il 1957 e il 1979).
«Testuale» n. 4, dicembre 1985