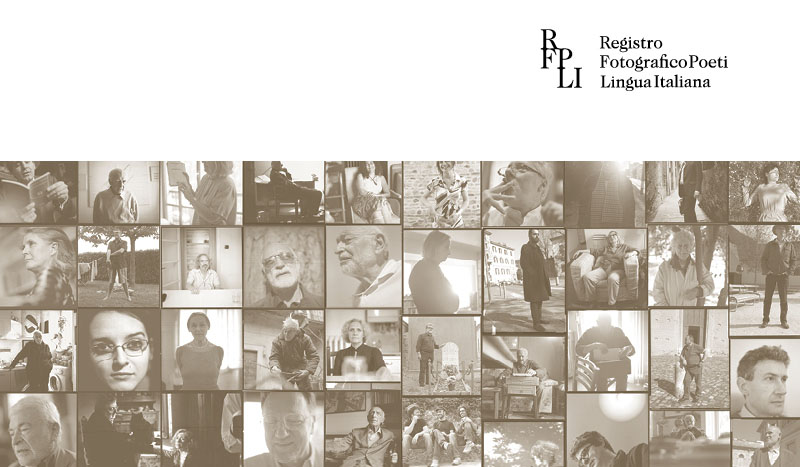ERNESTO CARAFOLI,
CHIMICO E DOCENTE UNIVERSITARIO
- Attraverso quali percorsi – di studio e di vita – è arrivato a occuparsi di biochimica e a insegnare al Politecnico Federale di Zurigo?
Ho studiato medicina, e a dire il vero l’ho fatto senza possedere una vocazione vera e propria, per una sorta di imperativo interno: vengo da una famiglia di medici, mio padre aveva dovuto abbandonare la ricerca in ambiente clinico universitario per dedicarsi alla professione, e si sentiva (e io lo sentivo) un po’ sprecato. Quindi ho scelto di frequentare medicina per fargli piacere, offrendogli quasi la possibilità di una rivincita morale. Allora ero forse più interessato a studi letterari o filologici, d’altra parte non ho vissuto questa decisione come un sacrificio o un’imposizione, conscio com’ero e come sono che vi è del positivo nel fare qualcosa che magari piace meno di altro ma è più gradito (serve di più) a chi ci sta intorno. Un discorso difficile da accettare oggi; comunque per me è stato così. Mi sono quindi laureato in medicina, scegliendo di lavorare nell’Istituto di Patologia generale di Modena, affascinato anche dalla figura morale e scientifica di Massimo Aloisi, un vero maestro, per me e per la cultura italiana dell’epoca. Un uomo di grande cultura, direi un uomo rinascimentale, e mi considero fortunato, molto fortunato, per averlo conosciuto. Non mi ha solo insegnato il mestiere, mi ha insegnato a vivere. Ho passato poi alcuni anni in Psichiatria, sentendo il richiamo un po’ misterioso un po’ romantico della malattia mentale; allora tuttavia questa scienza era insieme primitiva e violenta, non aveva tutti i supporti farmacologici che ha oggi e quindi mi ha stancato presto. Ero assistente universitario, e vinsi una borsa di studio del CNR per specializzarmi a Baltimora, all’Università John Hopkins: rimasi in America tre anni, e ne uscii biochimico. Per tutti gli anni ’60 feci la spola tra Modena e Baltimora, approfondendo sempre di più i miei interessi in campo biochimico: tornato definitivamente in Italia nel ’68, vissi con disagio sempre maggiore la difficoltà di fare ricerca nel nostro paese, e quando dovetti scegliere tra la cattedra di biochimica che mi veniva offerta da Politecnico di Zurigo e la cattedra di Patologia Generale che avevo nel frattempo vinto a Padova, optai per Zurigo, nel ’73. E non me ne pento.
- Come si svolge la sua attività di ricerca e quella didattica?
In pratica si devono distinguere tre momenti fondamentali: c’è la lezione su un argomento di biochimica, poi l’attività didattica con i laureandi e gli specializzandi, e infine il lavoro di ricerca e di laboratorio su cui ovviamente non subisco controlli di nessun genere, ma che è fondamentale e scontato dover proseguire ai più alti livelli, visti anche i mezzi che mette a disposizione il Politecnico. Il nostro primo corso di biochimica – al terzo semestre – è seguito da circa 150 studenti delle facoltà di farmacia, e delle diverse suddivisioni della Facoltà di scienze naturali. Di questi, una trentina scelgono di laurearsi in biochimica e 5-6 fanno la tesi con me.
- A quali rami della ricerca biochimica si interessa di più, e di cosa si occupa attualmente?
Per alcuni anni mi sono occupato di bioenergetica, cioè dei meccanismi di produzione di energia nelle cellule; in seguito ho studiato il controllo della biochimica cellulare, cioè i segnali che le cellule ricevono e decodificano; questi segnali sono trasmessi da tanti elementi diversi, il più importante dei quali è sicuramente il calcio. Mi occupo quindi di calcio, come elemento chimico “veicolo”, diciamo così, trasportatore di segnali.
- So che lei è un’autorità a livello mondiale su questo argomento.
C’è un po’ di retorica su questo: il fatto stesso di occupare una cattedra al Politecnico di Zurigo crea questa fama di autorità, non so poi quanto reale. Senz’altro molto comoda però, perché permette di ottenere riconoscimenti, di svolgere una funzione traente nell’organizzazione della ricerca internazionale, di avere finanziamenti molto più facilmente di quanto può accadere a un professore di un’università italiana.
- In quale lingua tiene le sue lezioni?
Per i primi due anni in inglese, oggi, dopo aver rinfrescato il tedesco con cui avevo familiarità da bambino, faccio lezione in questa lingua. In realtà, essendo il Politecnico un’istituzione federale, potrei esprimermi in una qualsiasi delle quattro lingue ufficiali in Svizzera (sì, anche in romancio che, essendo io friulano, mi è particolarmente vicino). Non ho mai accettato il dialetto svizzero come lingua di comunicazione, sia perché lavoro in un ambiente internazionale (una notevole proporzione dei docenti è straniera), sia perché lo svizzero è una lingua priva di tradizioni culturali vere, soprattutto una lingua che non si può scrivere, e con un vocabolario molto limitato, quindi sostanzialmente inadatta alla comunicazione scientifica. Piaccia o non piaccia, la lingua della scienza è oggi l’inglese: i nostri libri, i seminari, i congressi sono tenuti in inglese. E quindi uso soprattutto questa lingua.
- Quali sono le risposte più innovative che possiamo aspettarci dalla biochimica, oggi, nelle sue applicazioni concrete?
Di regola, la gente si aspetta risposte e applicazioni concrete in ambito medico: e infatti già possiamo fornire indicazioni precise su meccanismi di malattia che possono aprire la porta alla scoperta di interventi curativi, per esempio nella lotta al cancro. Ma ci sono altri campi di ricerca in cui la biochimica offre possibilità enormi di ricadute pratiche: la biochimica delle piante può essere utilizzata nello studio dei pesticidi, nel controllo dei raccolti, eccetera. La biochimica sta facendo progressi enormi e soprattutto progressi rapidi: si scoprono cose nuove ogni giorno, si ampliano orizzonti, scostandosi magari sempre più dalla chimica per avvicinarsi alla biologia, cioè ai processi della vita affrontati con metodiche genetiche, tossicologiche e così via.
- E a proposito di applicazioni pratiche della scienza, le recenti polemiche sull’ingegneria genetica la vedono ottimista o pessimista, riguardo al senso di responsabilità degli scienziati?
La coscienza collettiva è turbata dal problema etico, filosofico, posto dalle ricerche dell’ingegneria genetica: teme ad esempio che si possano sviluppare ceppi batterici nuovi e non debellabili, e che per dolo o per errore possano diffondersi tra gli uomini; oppure teme la creazione in laboratorio di mostri, o esperimenti su cavie umane. C’è, in questi timori, qualcosa di fantascientifico, un misto di demagogia e ignoranza; il compito più prossimo dell’ingegneria genetica è quello di intervenire su errori esistenti nei geni, e ancora non è pronta a fare ciò. Figuriamoci se si riesce a creare la vita in provetta! Le previsioni su questi punti che si leggono periodicamente nella grande stampa fanno sorridere.
- È indubbio però che il potere nella mani degli scienziati è enormemente aumentato; sono loro, oggi, i nuovi chierici? A loro è demandata l’interpretazione critica del reale, e magari anche la proposta di interventi correttivi? In altre parole, sono gli scienziati a guidare le regole del gioco oggi, o sono “guidati”?
Ci sono senz’altro scienziati “guidati”, che lavorano al servizio di grandi industrie, o di potenze militari. Il pericolo più diffuso è tuttavia un altro: quello cioè che l’uomo di scienza sia talmente affascinato dalla propria ricerca da non occuparsi di ciò che ne deriva, che insomma “veda i rami ma non la foresta”, e si chiuda nella classica torre d’avorio. C’è forse un peccato di presunzione, o di orgoglio, insito nell’animo umano: ed è quello di voler a tutti i costi aumentare la conoscenza, raggiungendo sempre nuovi obiettivi, ma disinteressandosi delle finalità ultime, della motivazione della propria ricerca. Fare lo scienziato “puro” è quindi cosa rischiosa ma sempre meno di quanto non sia fare lo scienziato “manager”, affarista; in questo senso anche la biochimica si è “corrotta”, e molti uomini di studio sono attirati dal miraggio di guadagni facili. Non vedo nulla di male nel collaborare con l’industria, ad esempio con la grande industria farmaceutica, per risolvere problemi di mutuo interesse, anzi. Vedo però molto di male, molto di corrompente, nell’adattare i propri piani di lavoro alle domande industriali, nel decidere il tipo di ricerca che si fa, in base alle domande dell’industria. Domande che ovviamente hanno una contropartita per il ricercatore che vi si adatta. Il punto di incontro deve essere diverso, e cioè basato sull’avanzamento della conoscenza, senza condizionamenti da parte del ricercatore universitario e sull’uso di questo avanzamento da parte di chi si rivolge alle applicazioni pratiche. Che queste poi siano fonte di guadagno mi pare del tutto normale.
- So dei suoi vasti interessi letterari, della sua conoscenza non superficiale del mondo dell’arte. Esistono ancora, secondo lei, “le due culture”? Capita spesso di conoscere umanisti interessati alla scienza e viceversa?
Le due culture esistono, eccome, e questa è un po’ la maledizione che incombe sulla cultura italiana dai tempi di Croce, la convinzione cioè che per essere colto non sia necessario conoscere il significato della parola neutrino o quale sia il principio di Pauli, mentre è fondamentale conoscere Montale. Io ritengo invece, con buona pace di don Benedetto, che nel XX secolo anche la scienza si debba considerare parte essenziale della cultura che nobilita l’uomo. Mi addolora il fatto che quando si parla di “fuga dei cervelli” dall’Italia, non si dia abbastanza peso all’enorme perdita che il nostro paese ha subito con la partenza di schiere di specialisti di scienza del calibro di Dulbecco o di Luria, di Segre, o di Rossetti, mentre si scatena un pandemonio per commentare l’annunciato (solo annunciato, naturalmente) esilio di storici o peggio di tuttologi di cui noi abbiamo ben poco bisogno. Certo, il linguaggio della scienza è un linguaggio difficile, che scoraggia chi non vi è preparato: ma anche gli altri linguaggi specifici (quello della musica come quello della poesia) non sono facili, eppure molti riescono a spacciarsi per intenditori, magari barando; invece nella scienza non si può barare: o uno sa o non sa. Nessuno può improvvisarsi esperto, e ciò scoraggia i mistificatori, i parolai.
- Lei fa la spola tra diverse università: USA, Svizzera, Giappone, Italia. Quali le sembrano le differenze sostanziali tra i vari metodi di ricerca? Come giudica la preparazione scolastica dei giovani universitari di questi paesi? Davvero l’Italia è tanto indietro nella preparazione scientifica dei suoi studenti?
Sono paesi molto diversi per tradizione culturale e per organizzazione sociale; direi poi che il Giappone costituisce una realtà a sé, non confrontabile con quelle occidentali. E’ un paese oggi all’avanguardia nel lavoro scientifico, soprattutto nel mio campo di studi, ed è sostenuto da un’etica professionale rigorosa, che lo imparenta un po’ alla Svizzera, ma forse ancora più esasperata che qui. Negli Stati Uniti si assiste a un fenomeno preoccupante e di tendenza opposta: per più di un decennio ormai le amministrazioni di governo hanno demotivato i giovani brillanti intenzionati ad abbracciare la carriera scientifica. Di fatto, questo paese sta perdendo il ruolo faro della ricerca mondiale, anzi negli ultimi anni, con il taglio ai fondi per l’università, la situazione è notevolmente peggiorata, e finirà per aggravarsi ulteriormente alle soglie del duemila; al punto che noi europei abbiamo concrete possibilità di superare i nostri maestri. La Svizzera è un paese ben organizzato, che dà condizioni di lavoro ottimali e sfrutta qualsiasi possibilità di migliorare il suo livello scientifico, per esempio servendosi anche di ricercatori stranieri o affidando i vertici della sue università a docenti non svizzeri: quale sia l’apporto originario svizzero a questa rosea situazione scientifica è difficile dire, perché appunto ricorre molto spesso a persone che sono state preparate altrove. Non bisogna sottovalutare però il materiale umano su cui noi possiamo lavorare al Politecnico: gli studenti, che al Politecnico di Zurigo sono eccezionali, molto ben preparati, anche perché la selezione – drastica e traumatizzante per i ragazzi – si fa a monte, e all’università arrivano effettivamente solo i migliori. In Italia, invece, è tutto molto diverso: c’è dell’ottimo materiale umano, sia tra i docenti sia tra gli studenti, un enorme entusiasmo, direi quasi un’eccitazione per ogni “avventura” scientifica. Però nei ragazzi trovo delle lacune culturali spaventose, frutto della demagogia e dell’approssimazione che sono state la regola nella nostra università da circa un ventennio. Il ’68 è stata un’esperienza importante, una grossa ventata di aria fresca che ha spazzato via l’accademismo feudale in cui ci dibattevamo, ma ha segnato anche l’inizio di uno sfascio a cui le forze politiche e culturali non hanno saputo porre rimedio. Temo che per lungo tempo si sia voluto tentare di cavalcare la tigre, e i nodi, come d’altronde era ovvio prevedere, ora arrivano puntualmente al pettine. Un grosso problema consiste nella struttura dell’università, che garantisce un posto a vita a ricercatori poco più che adolescenti che avrebbero assoluto bisogno di frequentare ambienti di lavoro diversi, anche e soprattutto all’estero, per imparare e per sprovincializzarsi. Si blocca così qualsiasi avvicendamento, ma anche ogni possibilità di premiare i meritevoli. E’ un malinteso senso di democrazia, quello che vuole assicurare il “nulla” a tutti. Purtroppo, per parafrasare Gobetti, “l’università è l’autobiografia di una nazione”, rispecchia bene i problemi che l’Italia ha laddove vince l’ottusità burocratica, il malcostume politico, la chiacchiera vuota. Ci sono alcune isole che si salvano, delle facoltà in cui si lavora e si produce, ma grazie al sacrificio personale e culturale dei professori che sono rimasti, e di cui ho il più grande rispetto. Mi è difficile non pensare per loro al tempo degli amanuensi.
- Lei è anche membro del Consiglio Direttivo del Liceo Artistico Italo-Svizzero di Zurigo. Cosa pensa di questa iniziativa?
Raggiungerà senz’altro il suo obiettivo di fornire uno sbocco ai ragazzi svizzeri e agli italiani che vivono qui, spesso ingiustamente penalizzati da questo sistema scolastico che nella selezione è crudele e usa troppa poca elasticità. Avrebbe potuto essere, questo Liceo, qualcosa in più: aprirsi anche agli italiani che risiedono in Italia e costituire un momento d’incontro tra due culture diverse e complementari. Indipendentemente da ciò, è fondamentale il fatto che una istituzione svizzera si serva di personale italiano per fornire un servizio culturale ai suoi cittadini: questa è una novità che speriamo tutti gravida di implicazioni e suggerimenti per il futuro.
«Agorà»» (Svizzera), 17 gennaio 1990

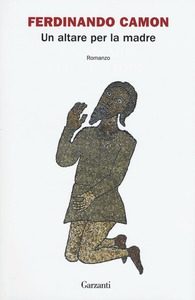






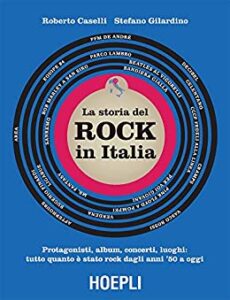
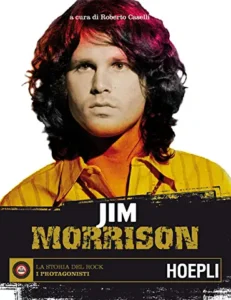
 cantautori storici Luigi Tenco, Paolo Conte, Francesco De Gregori, Ivano Fossati e Gino Paoli che ha dato il via alla stagione. Tra le nuove generazioni mi piace Brunori Sas anche se ormai non è proprio quel che si dice un ragazzino.
cantautori storici Luigi Tenco, Paolo Conte, Francesco De Gregori, Ivano Fossati e Gino Paoli che ha dato il via alla stagione. Tra le nuove generazioni mi piace Brunori Sas anche se ormai non è proprio quel che si dice un ragazzino. dei musicisti che lo interpreta si auto-produce e proprio per questo può permettersi di essere uno dei potenziali esempi di critica sociale più efficaci.
dei musicisti che lo interpreta si auto-produce e proprio per questo può permettersi di essere uno dei potenziali esempi di critica sociale più efficaci.