LA CALUNNIA
Ci alzavamo di solito verso le sette: io un po’ prima, magari, per gustarmi da solo la sigaretta con il caffè, seduto al tavolo della cucina, apparecchiato con le tovagliette all’americana. Dedicavo a me stesso, così, i primi dieci minuti della giornata, ricapitolavo gli impegni dell’ufficio, gli appuntamenti di lavoro, eventuali compiti di padre (colloqui con i professori, shopping con i ragazzi…). Bevevo il caffè con il dolcificante, tanto per mentirmi sull’attenzione che bisogna porre al proprio aspetto fisico: e invece mi sapevo e mi piacevo sempre più trasandato, poco curato nei vestiti e nelle cravatte, ingrigiti i capelli e rugosa la fronte. La pancia, poi, non più contrabbandabile con gonfiori epatici.
Spalancavo le imposte del salotto e della mia camera, con lentezza e attenzione, perché nessun tonfo disturbasse il sonno leggero e isterico della suscettibile vicina di sopra. Poi svegliavo i ragazzi, che nelle loro camere, ancora sprofondati in un sonno privo di scrupoli, dormivano atteggiati secondo i loro rispettivi caratteri: Michele, con il piumino mezzo sul letto e mezzo sul pavimento, attorcigliato tra i polpacci, la testa quasi del tutto coperta dal cuscino, e i capelli lunghi arruffati sulle spalle. Ribelle anche nel sonno, anche con il sonno dei suoi sedici anni. Francesca angelica e composta, supina, con le mani semiaperte vicine alla testa. Questa era la routine, da quasi tre anni, da quando mia moglie Natalia se ne era andata, distrutta in pochi mesi da un tumore al pancreas.
Approfittavo del lento, litigioso, ripetitivo risveglio dei miei figli (colazione in pigiama, riassetto della stanza, musica diversa dai due diversi stereo) per chiudermi in bagno e dedicarmi alle abluzioni quotidiane: e anche lì dovevo tenere a freno i miei nervi se l’acqua non scorreva nel lavandino a causa del groviglio dei capelli attorcigliati al tappo, se il tubetto del dentifricio era strozzato a metà, se lo specchio era sporco di schiuma e goccette varie.
Lo specchio: che immagine di me mi rimandava, impietosa! Che viso stanco di prima mattina, pelle opaca, labbra tirate. Ero ancora un bell’uomo? Un cinquantenne appetibile? Sorridevo strano, ricordandomi le raccomandazioni del mio vecchio dentista: «Ridi, Piero, ridi! Hai i denti belli e forti, una faccia simpatica: ridi! Fai vedere che la vita ti piace, che la gente ti piace, che sei capace di allegrie, di entusiasmi!» Ma io ridevo poco già da ragazzo, e negli ultimi tempi mi ero davvero incupito: in realtà non mi piacevo, non mi piaceva più la vita e trovavo insopportabilmente noiosa la gente.
Quella mattina, entrai nella stanza di Francesca per aprire le finestre ancora chiuse, e lasciare che un po’ della sana nebbia novembrina della nostra umida città veneta raffreddasse l’aria. I venti metri che mi dividevano dalla finestra dei signori Caporali, il velo brumoso che riempiva l’atmosfera non mi impedì di notare l’occhiata severa della moglie caporalessa, in vestaglia rosa e con una coperta in mano, il suo non saluto al mio cortese cenno di testa, la sua rapida ispezione alla camera della ragazzina dove mi trovavo. «Bah!», pensai, avrà litigato col marito e odierà tutti gli uomini; oppure la menopausa, oppure suo figlio avrà avuto da dire con Michele per il posteggio del motorino. Non me ne feci un cruccio, e velocemente mi vestii, urlando ai ragazzi di fare altrettanto, e di sbrigarsi.
Li accompagnavo a scuola, nello stesso istituto semiprivato dove andavano tutti i figlioli bene della città: rampolli di bancari, avvocati, politici, medici. Operai non ce n’erano, impiegati e insegnanti pochi. Michele frequentava con grossi insuccessi e evidente fastidio, suo e dei professori, la quinta ginnasio: sua sorella, bravina e matura, la terza media.
Parcheggiai come al solito la mia Renault in terza fila, feci un rapido ciao al ragazzo, porsi la guancia per il bacio alla bambina, seguendoli con la coda dell’occhio fino all’affollato portone d’ingresso. Mentre giravo la chiavetta per ripartire, scoprii su di me lo sguardo fisso e interrogativo dell’ingegner Berti, l’espressione stupida e ansiosa di sua moglie. Erano rappresentanti dei genitori: fosse successo qualcosa nell’ultimo consiglio di classe? Sapessero di qualche grave mancanza dei miei figli? Cercai di sorridere cordiale, accompagnando il sorriso con un cenno rassicurante della mano. Risposero imbarazzati e serissimi, scambiandosi poi un’occhiata che vagava tra il sospetto e l’incredulità. Mi sentii mortificato, pensai di chiedere bonariamente una qualche spiegazione, ma la loro Audi ripartì sgommando veloce.
Ci mettevo meno di venti minuti a raggiungere la sede dell’Inps, dove da poco più di tre mesi mi avevano promosso capo del personale. Mi ero buttato nel lavoro testa e corpo, cuore e volontà: non per ambizione, e nemmeno per fare le scarpe a qualcuno, ma perché era l’unica cosa in cui riuscivo ad annullarmi totalmente. E i risultati non si erano fatti attendere. Senza vantare alcun padrino, politico o sindacale, o altra influente amicizia, avevo inaspettatamente superato due titolatissimi candidati: alla loro invidia, ai pettegolezzi di corridoio avevo risposto volando alto. E ora godevo, ma senza esibizioni o vanterie, che rimanevano estranee al mio carattere, di un discreto stipendio, della collaborazione fedele di due competenti segretarie, di uno spazioso ufficio fornito di ogni sussidio informatico e vista su uno dei più trafficati viali cittadini.
È incredibile come avvenimenti esteriori, e fondamentalmente estranei all’anima e alla vita vera di una persona, possano apparire alla sensibilità altrui più incisivi e radicali degli sconvolgimenti drammatici che distruggono l’esistenza. Alla morte di mia moglie, avevo subito avvertito intorno a me un sentimento misto di pena e imbarazzo: ma nulla che modificasse sostanzialmente la considerazione che si aveva di me. Con la mia promozione, invece, era subentrata in chi mi avvicinava una meravigliata e accresciuta stima, una deferenza impacciata che mi irritava abbastanza. Così anche quel giorno mi aspettavo, entrando dalla porta a vetri a pianoterra, il saluto rispettoso del portiere: «Buongiorno dottore!», la cordialità timorata delle impiegate, il cenno amichevole dei colleghi. Ma sembravano tutti impegnatissimi, di fretta, presi in chissà quale vortice di scadenze e pressioni.
Salii con l’ascensore al sesto piano, chiudendomi alle spalle la porta dell’ufficio, e mi immersi nello spoglio della corrispondenza. Dopo poco si affacciò Susanna, la più giovane delle segretarie, come al solito ben truccata e in tiro, abbronzata di chissà quante sedute alla lampada, tacchi alti e tailleurino attillato. Doveva farmi firmare un ordine di servizio, e visionare altre carte. Ma mi sembrava un po’ sulle sue, meno propensa del solito allo scambio di battute. La presi vagamente in giro, alludendo con paterna benevolenza a esaltanti strapazzi notturni. Fui gelato dalla sua risposta tagliente: «Farebbe meglio a occuparsi delle sue notti, dottore», e dallo sguardo pesante che mi rivolse. La osservai uscire impettita e offesa: anch’io offeso, e turbato.
Le mie notti? Mi chiesi. Di quali notti parlava, a quali disinvolture alludeva? Ricapitolai mentalmente le mie sere ultime, delle ultime settimane, degli ultimi mesi. Ore passate davanti al computer a giocare a Free Cell o a battaglia navale, libracci gialli divorati e dimenticati in poco tempo, qualche film del palinsesto notturno alla TV: e un sonno leggero, turbato dal minimo rumore e da sogni ansiosi. Donne? Nessuna. E dove e come, poi, avrei potuto? Portarmele in casa, con la gelosia feroce dei ragazzi, che mi spiavano agitati ogni cartolina, ogni telefonata? Uscire, non uscivo. E non sapevo più corteggiare, fare complimenti, sorridere galante.
Con quanto tremore, con quale impaurito imbarazzo osservassi le dita affusolate di una commessa ai grandi magazzini, come potesse turbarmi la dolcezza di una voce femminile al telefono, lo sapeva solo il punto più buio e sensibile della mia anima, il mio corpo trepido tornato adolescente. Ricordavo la tenerezza dei primi incontri con mia moglie, la scoperta affannata e riconoscente della morbidezza del suo seno. Non riuscivo più a guardare nessuna donna senza pensare a quello che suggerivano, nascondendolo, maglioncini attillati, camicioni mimetizzanti: e ogni sguardo mi faceva sentire in colpa, ogni accenno al corpo mi offendeva come uno sputo.
L’avevano finalmente capito parenti e amici intimi, che dopo l’insistente indelicatezza dei primi tempi di vedovanza («Nessun uomo può stare senza una donna», «I tuoi figli hanno bisogno di un’altra mamma», «Devi volerti più bene” …), mi avevano lasciato in pace. Perché mi ribellavo dentro, ad ogni allusione alla mia sessualità, ad ogni intrusione pettegola nel mio privato: mio, mio, e solo mio. Mi capitava di sfiorare con le labbra il cuscino, la notte; o di accarezzare una parete, una sedia, pensando alla pelle di una donna. A chi dovevo rispondere di questo? Ai miei disinvolti colleghi, alle segretarie da discoteca che mi giravano intorno, desiderose di provocarmi, di eccitarmi? Com’erano state premurose e comprensive, negli ultimi anni, le mogli dei miei amici, nelle loro esibite attenzioni: materne, sororali, complici, insistenti come zanzare, nel proporsi vicemadri, zie putative. Alla corte assidua di una di loro avevo ceduto, una sera, rimediando una figura barbina, un tonfo assoluto, che la signora non mancava di sottolineare con un vacuo sorriso di superiorità, le poche volte che mi succedeva di incontrarla.
Quella frase cattiva di Susanna, «Pensi alle sue notti, dottore!», continuò a ronzarmi in testa, enigmatica, per tutta la mattina: ribadita nella sua inspiegabilità dall’imbarazzo timido e sfuggente con cui venni trattato anche dall’altra impiegata, più anziana e esperta, di solito molto energica e spiccia. «Antonietta», finii per chiederle, «È successo qualcosa?» «Non saprei, dottore, non saprei», continuava a negare, e intanto girava gli occhi intorno, supplicando qualsiasi divinità di tirarla fuori dall’impiccio, di fornirle un appiglio cui aggrapparsi. «Mi sembrate tutti così strani… E non solo qui in ufficio. Anche i vicini, e alla scuola dei ragazzi…» «Non saprei. La gente, a volte, ha i suoi problemi. Non so cosa dirle, davvero». Non riuscii a farle aggiungere altro.
Quel giorno, e i giorni successivi, passarono all’insegna del silenzio. Nessuna chiamata al telefono, nessuna visita a casa. Anche i ragazzi venivano evitati dai compagni. Addirittura, alla festa di compleanno di Francesca non si presentò nessuno, accampando le scuse più varie e inverosimili. La ragazzina era stranita, incredula: «Forse perché ho preso due ottimo negli ultimi compiti», cercava di convincere se stessa e noi, «Forse perché non ho suggerito all’Eliana durante l’interrogazione di scienze». Ma non credeva alle proprie giustificazioni. Mi costrinse a un colloquio con la professoressa di lettere, prima delle udienze generali, e dovetti chiedere un permesso in ufficio.
L’insegnante mi accolse gelida, ben diversamente dai precedenti incontri, in cui si era dimostrata simpaticamente solidale con me e con le mie difficoltà di genitore solo. Adesso mi scrutava negli occhi quasi volesse denudarmi l’anima, e parlava a monosillabi, severa, di un improvviso disagio di Francesca, di una sua tenace chiusura a riccio. «La ragazza è distratta, poco concentrata. Sta soffrendo». E mi guardava accusatoria. Mi sentivo sul patibolo, balbettavo che mia figlia pativa l’inspiegabile comportamento dei compagni di classe, che da qualche tempo la escludevano dalla loro compagnia, senza alcuna motivazione logica. Il commiato della professoressa fu lapidario: «Non credo che la scuola abbia responsabilità per quello che vi succede». La mano che le porsi rimase sospesa a mezz’aria, senza ricevere nessuna stretta di risposta.
In qualsiasi modo cercassi di chiarire l’argomento, di ottenere spiegazioni, ricavavo solo silenzi imbarazzati, sguardi ostili, sorrisi sprezzanti. Il comportamento dei miei conoscenti sembrava contagioso: dal nostro condominio a tutta la strada, al quartiere intero; dall’ufficio alle banche agli uffici postali. Un tam-tam misterioso e impalpabile stava facendo di me un paria, un Barbablù infrequentabile.Tentai di affrontare la questione con mio fratello, dapprima al telefono, poi di persona. E lui farfugliava, un po’ negava tutto, un po’ mi dava del visionario e dell’esaurito, un po’ sembrava a conoscenza di accuse indicibili che forse condivideva.
«Mi guardano tutti, per strada. Mi trattano male nei negozi». «Ma quando mai? I commessi ormai sono scortesi sempre, nessuno ha più la pazienza di servire. Sei tu che non sai frequentare le persone, così serio, nemmeno una battuta di spirito, un complimento. Chi ti credi di essere?» «Guarda che una cosa del genere non mi è mai successa in tutta la vita. Dev’esserci un equivoco, uno scambio di persona». «No, il fatto è che non vuoi ammettere le tue debolezze, i tuoi difetti. Pecchiamo tutti. Parlane con qualcuno che ti aiuti, uno psicologo, un confessore».
Pecchiamo tutti? Se sollecitavo un chiarimento, si rimangiava ogni parola, contraddicendosi, sbuffando, o ridacchiava allusivo, ammiccando a chissà chi, nell’aria. Poi, subito dopo, il mio gaudente fratello diventava moralista, catone severo: «I tuoi figli hanno bisogno di un padre da amare, da stimare. Un padre-esempio». Ogni parola che diceva mi squarciava veli dagli occhi e piaghe dentro; non sapevo se leggere nel suo sguardo odio, disprezzo o pena.
Cominciarono presto le telefonate anonime, prima di solo disturbo: riagganciavano al nostro «pronto?», quattro-cinque volte al giorno. Poi gli insulti, le parolacce, soffiate ansimando, o urlate con accento dialettale. Cercavo di rispondere sempre io, al posto dei ragazzi, e di fingere indifferenza, di dire bugie («Hanno sbagliato numero»); ma a volte esplodevo, rabbioso, gridando tutto il mio rancore di bersaglio incolpevole, di vittima impossibilitata a difendersi. E Francesca scoppiava a piangere, terrorizzata.
Una domenica successe qualcosa di ancora più grave. Avevamo rinunciato ad ascoltare la Messa nella nostra parrocchia, perché intorno al nostro banco si era creata una specie di cordone sanitario: nessuno ci sedeva vicino, nessuno si voltava o avvicinava a scambiare il segno di pace. Così da circa un mese frequentavamo la cappella di un convento francescano, un po’ fuori città. Era molto suggestivo, per me, immergermi in un’atmosfera che manteneva nei suoi riti qualcosa di ascetico, il fascino di un misticismo che accondiscendeva a banalizzarsi, nell’ora della Messa, per i profani che mai sarebbero riusciti, da soli, a raggiungere un tale raccoglimento. La sofferenza di quelle settimane mi aveva reso particolarmente sensibile alla Parola delle Scritture, al commento di alcune pagine del Vangelo la cui verità, in passato, avevo solo intuito, senza comprenderla fino in fondo. I ragazzi mi seguivano controvoglia in questo mio entusiasmo, che subivano soprattutto per restarmi vicini.
Quella domenica, appunto, il più giovane dei presbiteri, alto e occhialuto, che ci era stato descritto come plurilaureato e specialista di San Paolo, durante la preghiera dei fedeli scandì, con forte accento lombardo, alcune parole che mi incenerirono, perché le riconobbi senz’ombra di dubbio indirizzate alla mia persona, che non ritenevo lui dovesse conoscere. «C’è qualcuno in questa nostra comunità che ha compiuto un peccato, un peccato grave, di fronte agli uomini e a Dio: e ora vive nella colpa, nella vergogna, evitato e isolato da tutti. Paralizzato dal rimorso, incapace di risollevarsi. Preghiamo perché trovi la forza di chiedere perdono, e di tornare a guardare negli occhi il suo prossimo». Tra i cinquanta fedeli che risposero al suo invito, «Preghiamo», più di uno mi rivolse pesanti sguardi di condanna. E io, non perché fossi o mi sentissi colpevole, ma perché avvertii pesantemente che gli altri mi ritenevano tale, abbassai gli occhi, e le mani mi tremavano.
Da quella notte cominciai a non dormire, a sentirmi spiato e segnato a dito ovunque andassi. Dovetti iniziare una terapia, e chiedere un congedo per motivi di salute in ufficio. Il dottore che mi aveva in cura era assolutamente convinto di trovarsi davanti a una nevrosi grave, e addossava alla mia malattia la causa di tutto ciò che mi accadeva. Io ero molto docile nel seguire le sue indicazioni, nell’assumere con precisione tutti gli psicofarmaci che mi ordinava; recalcitravo però davanti alla sua insistenza nell’esplorarmi sentimenti consci e inconsci, nello sviscerare il mio passato dall’infanzia: come davanti a un’ingerenza indebita, a una violenza che mi si faceva all’anima. Intuivo poi confusamente che anche lui mi nascondeva qualcosa, quasi volesse difendermi da una mia reazione esasperata di fronte a una verità che avrei sentito come sconvolgente, insopportabile.
La cura durò mesi, e non risolse nulla. Vivevo intontito, intorpidito, incapace di una qualsiasi azione: incapace soprattutto di valutare nelle giuste proporzioni ciò che mi succedeva intorno, di difendermene, trovando scampo nelle poche cose che ancora contavano per me.
Lo sguardo degli altri, il loro giudizio, era diventato la cartina di tornasole di ogni mia giornata, come se io non fossi più io, come se dubitassi delle mie azioni, della mia coscienza. Il sospetto degli altri, ormai, mi faceva sospettare di me stesso. Per timore di leggere, in chi frequentavo, un qualsiasi imbarazzo, o anche solo un interrogativo, finii per non frequentare più nessuno. Per strada camminavo veloce, guardando in alto, evitando di salutare chicchessia.
In ufficio mi ero chiuso in un mutismo iroso, permaloso, sottraendomi a ogni innocente scambio di battute che esulasse dal campo lavorativo, rispondendo con durezza e disprezzo alla durezza e al disprezzo altrui. Nessuno arrivava a dirmi in faccia di quale misfatto mi fossi macchiato, di cosa concretamente mi si accusasse: e il silenzio e l’omertà di tutti diventavano più colpevoli, ai miei occhi, della responsabilità attiva di chi avesse voluto farmi del male.
Decisi di provare a difendermi con la legge, anche se combattere una guerra contro un nemico sconosciuto è più difficile che ignorare chi si conosce perfettamente. Così mi presentai alla caserma dei carabinieri più vicina, emozionato, intimidito: a denunciare cosa? Che parlavano male di me, che mi evitavano? Telefonate di disturbo, parolacce per strada? Ma in città rubavano cinque auto al giorno; droga, prostituzione, truffe, violenze venivano considerate banalità quotidiane. Mi avrebbero riso in faccia.
Così fu, circa. Venni introdotto nell’ufficio del maresciallo di servizio, un tipo tarchiato, col viso inciso dalle cicatrici di un’acne giovanile, e con un ridicolo accento meridionale risciacquato in quello veneto. Fece finta di non conoscermi, ma avevo intuito dal suo involontario sobbalzare alla mia presentazione che in realtà mi conosceva benissimo. Con molta titubanza cercai di renderlo partecipe dei miei problemi, ma mi trovai di fronte a un muro di gomma, fatto di battute e di sorrisini allusivi, a mezze frasi del tipo: «E cosa ne so io di che vita fa o ha fatto lei? Cosa mi importa delle sue abitudini sociali o sessuali? Ma si guardi allo specchio: cosa vuole che si pensi di una persona come lei? Sapesse quello che si dice in giro di me! Ma io me ne frego, me ne frego: mica mi ammalo, io, non vado dagli psicanalisti, io!»
Si può prendere a sberle un maresciallo dei carabinieri, si può mandarlo al diavolo? Avrei potuto rispondere che era più facile far ammalare una persona piuttosto che guarire una città dall’idiozia, ma chissà se avrebbe capito. Me ne andai sconvolto e incredulo, rinsaldato nei pregiudizi che per tutta la vita avevo nutrito nei confronti dell’Arma e delle divise in generale.
L’assillo di comprendere, di dare un volto e un nome alla persona o alle persone che mi stavano distruggendo la vita, mi portò nel giro di due settimane a rivolgermi prima a un detective privato, che declinò subito l’incarico, e poi a uno dei migliori avvocati della città.
Ci eravamo conosciuti da giovani, frequentavamo la stessa facoltà in una città vicina: poi le nostre strade si erano divise, ma io l’avevo seguito nei suoi successi professionali e politici, puntualmente riportati dalla stampa locale, sempre provando un’ammirazione critica e sospesa: perché, da ragazzo, non l’avevo mai considerato granché. Aveva uno studio avveniristico, tutto specchi e librerie cubiche, componibili, colorate: e quadri alla Pollock appesi nei pochi spazi liberi. Poltrone e divani in stoffa rossa, facevano pensare più all’anticamera di un dentista postmoderno che a un avvocato. Lui non assomigliava al luogo. Già robusto da giovane, ora strabordava. Calvo, con gli occhiali spessi, un vestito di velluto piuttosto stazzonato; era comunque una persona sussiegosa, ossequiosa, un po’ viscida.
Non sembrò felice di vedermi, e appena gli chiesi se era in grado di assistermi in una denuncia per diffamazione e calunnia, cominciò a parlare parlare parlare, com’era nelle sue abitudini e nei suoi doveri. Che denunce di quel genere erano inutili, facevano sprecare tempo e denaro, terminando nel 98% dei casi con un’archiviazione; che tra maldicenza, diffamazione e calunnia i confini distintivi erano sottili e quasi inafferrabili. E che comunque la cosa avrebbe avuto, da un qualsiasi processo, una risonanza senz’altro controproducente nei riguardi della mia reputazione. Che non aveva nessun bisogno di essere difesa. Che lui mi garantiva non essere stata intaccata minimamente dalle chiacchiere di una cittadina provinciale come la nostra. Che mi conosceva da sempre, e non aveva dubbi sulla mia integrità. Avevo però mai pensato a trasferirmi altrove? Non per niente, ma per la tranquillità dei miei figli, per la mia salute, per il mio futuro di professionista e di uomo.
Mi congedò più affabile di quanto fosse stato all’inizio, ma nell’accompagnarmi alla porta, nel porgermi la destra grassa, ebbe un lampo negli occhi. «Stai tranquillo. Sei una brava persona, un ottimo padre». (Forse. Chissà. Sarà vero o no. Io la mano sul fuoco non ce la metto per nessuno).
Appena fuori, mentre aspiravo a fondo per pulirmi i polmoni, con i pugni stretti nelle tasche dell’impermeabile, sentii piano piano che il fango di quello sguardo mi scivolava via, dal cuore e dai vestiti, dalla pelle e dai pensieri: mentre sarebbe continuato a crescere in chi, del male – altrui e proprio – faceva il suo nutrimento quotidiano, fino a imbastirsene le fibre dell’anima, rimanendone invischiato del tutto. Preti, poliziotti, avvocati, e le persone che proiettavano su di me la sporcizia loro: io dal fondo di quella melma che non mi apparteneva, uno spiraglio per guardare in alto, oltre i tetti delle case, l’avrei trovato.
Chiesi aiuto all’aria, che mi pulisse la mente, portandosi via con il respiro che emettevo dalle labbra socchiuse, anche il dolore.
In Qualcosa del genere, Italic Pequod, Ancona 2018
LA LEPRE ALPINA
Aveva scelto il momento di maggior affollamento delle piste: le undici e mezzo, con il sole che batteva sulla neve riflettendosi in bollicine azzurre e gialle oro, ai confini della montagna tagliati di netto contro il cielo tersissimo, e le sagome vivaci multicolori di ragazzi e ragazze sfreccianti dai pendii, zigzaganti dal colmo di cunette all’avvallamento del lato opposto. Si era messa la tuta più leggera, la sua bella giacca nuova di un verde brillante e i calzoni elasticizzati ormai sfruttati da diversi anni, ma ancora così comodi per affrontare gite impegnative come quella che si proponeva di fare. Lo zainetto zeppo di cibarie. Cioccolata, soprattutto, di cui era golosissima, e poi succhi di frutta, un paio di guanti di riserva, occhiali da sole, creme, la mappa dei sentieri fuori pista e dei rifugi. In fondo a tutto, il borsellino con una cifra che giudicava dignitosa. La fila allo skilift era, come al solito, caotica e vociante; bambini velocissimi col casco si insinuavano in ogni spazio lasciato vuoto tra due persone.
Davanti a lei, una specie di orso in tuta da sci nera, con cappuccio col pelo e bavero rialzato, in modo che della sua faccia si distinguevano solo le lenti scure e i baffoni folti, si spostava goffo e ammiccante, di qua e di là, quasi dovesse scusarsi con chi gli stava vicino della propria corpulenza invadente. Dall’altoparlante, dolciastre musiche natalizie a ricordare che sì, era proprio il 25 dicembre, ma non gliene importava niente a nessuno: tutti avrebbero rinunciato alla messa al pranzo in famiglia alla tombola per una discesa in più, per un’abbronzatura invidiabile. Si trovò fianco a fianco con l’omone in nero, sempre impacciato e timoroso, pronto ad afferrare l’ancora che li avrebbe trascinati in alto con la foga di un naufrago cui si getta il salvagente. La sbilanciò non poco il guizzo di lui, e si ritrovò a ondeggiare verso destra, infastidita e supponente. «Faffondo?» le chiese lui, proprio così, legando verbo e complemento oggetto, con un accento non certo di lì, piuttosto romano, o abruzzese. «Faffondo?» Lei non rispose ma alzò una gamba come a dirgli “non vedi?”, con quegli sci ai piedi cos’altro poteva fare? «Bbello» si rispose da solo. «ce vo’ coraggio, e passione». Non la smuoveva dal suo silenzio ostile, e allora prese a mugolare dietro alla musica con il carillon di Jingle Bells, battendo il tempo al punto che il filo dello skilift ballonzolava in maniera impressionante. La salita sarebbe durata quasi dieci minuti, e all’idea di sentire il suo vicino canticchiare a quel modo per l’intero percorso, le venne improvvisa l’ispirazione di tagliare per la Trosa, spingendosi fuori pista e risalendo da sola fino al bosco. Diede uno scarto improvviso di lato, mollando l’ancora al peso non più controbilanciato del compagno. Sentì una mezza imprecazione di lui, e poi un più indulgente «Bonnoel, bonnoel!», che forse la credeva francese. Alzò il braccio quasi a scusarsi, o a salutarlo, o a mandarlo a quel paese, e scivolò leggera e felice sulla neve candida, invidiata dagli sguardi delle formichine telecomandate rimaste appese allo skilift.
La neve era perfetta, né molle né dura, sfrigolava appena al contatto con i suoi sci, ma era un fruscio dolcissimo e discreto, amico all’orecchio e al pensiero innamorati del silenzio. Non era stato nemmeno necessario puntare le racchette, scendeva diagonalmente inaugurando una strada nuova, e lasciando dietro di sé due tracce sicure nella loro parallela essenzialità. I suoi sci erano come lei: stretti, lunghi, elastici e resistenti. E poi, come lei, amavano correre da soli, da soli faticare, lontani da solchi già tracciati, indipendenti e superbi. Il bosco era a quindici minuti buoni di marcia, sembrava aspettarla quieto e misterioso, volerle promettere un rifugio sobrio, di legno e foglie aghiformi e resina. «Sarà il Natale più bello della mia vita» pensò contandosi i suoi ventitré anni addosso. «Un Natale senza parole». Il silenzio era infatti la presenza più tangibile, ritmato com’era dal respiro di lei, non ancora affannoso, ma già più pesante, e dal sibilo degli sci. Un Natale con Dio, lontano dalle creature di Dio: la montagna sopra di lei incombeva immobile e consapevole della sua perfezione, distante come il cielo azzurrissimo, irraggiungibile. «Nessuno sa che sono qui», si consolava al pensiero di ciò che aveva evitato, bacioni ai parenti, regali ai nipotini piagnucolosi, e il cotechino e il panettone.
Beveva l’aria fresca a sorsi ghiotti, sentiva i suoi polmoni espandersi, macchine impeccabili, così autonome dalla sua volontà; i muscoli delle braccia e delle gambe rispondevano automaticamente a messaggi involontari della sua mente, si muovevano regolari e spediti, orgogliosi del loro esemplare funzionamento. Mancavano ormai circa trecento metri al primo gruppo di abeti. Il sole batteva forte e le tirava la pelle sugli zigomi. Si sentiva scottare la faccia, e goccioline di sudore scendere lungo la fronte. Si fermò un attimo, piantando i bastoncini nella neve e appendendosi, quasi, alle manopole: si lasciò oscillare, spingendo gli sci avanti e indietro, in una sorta di ginnastica fanciullesca e ripetitiva. Si scopriva bambina scappata dalla sorveglianza adulta; prese una manciata di neve, se la strofinò sulla faccia e se ne riempì la bocca. Poi si strappò via il berretto di lana, liberando i capelli oppressi e impigriti, scosse la testa a farseli cadere sulla fronte, e di nuovo si innevò completamente, “sono un albero di Natale”, pensando, sbattendo le palpebre sotto la frangia bagnata.
Entrò nel bosco zitto, nell’aria zitta, e a bocca chiusa e zitta riprese il passo veloce di prima, lungo una stradina tra gli abeti che aveva percorso altre volte, ma sempre in compagnia: questa volta così sola, si sentiva sorella di ogni abete, una ragazza gnomo padrona e signora dell’intera vallata. Aspettava che qualche scoiattolo si calasse dai rami a renderle omaggio, e allora anche lei si sarebbe prostrata ad adorare la natura e il suo regno. Scivolava evitando i fusti che le venivano incontro improvvisamente, muti: ogni tanto spezzava una fronda e allora la investiva cadendo una massa soffice di nevischio, sparpagliandosi poi molle e cancellando le tracce dei suoi sci, così che del passaggio di lei non rimaneva niente. Sciava da due ore e non era stanca, decise però di uscire dal fitto degli abeti, costeggiando il versante sud della montagna, in direzione del rifugio. Le fu facile orientarsi, calarsi dritta giù nella valle e lasciarsi la boscaglia più fitta alle spalle. Quando il sole le fu di nuovo addosso imperioso, avvolgendola di luce e offrendole la compagnia, ora, di un’ombra fedele, decise di concedere sollievo al suo corpo: sganciò gli sci, si sdraiò supina e crocefissa nella neve, a occhi chiusi, a pensieri spenti. Sentiva i piedi allungarsi in radici, le mani rattrappirsi in zampette, il tronco sciogliersi in acqua. Perché sono nata donna e non abete, o lepre montana, o neve? Celebrò il suo Natale con mezza stecca di cioccolata e un succo di pera, brindò al bue all’asinello e alla stalla, e si addormentò.
La slavina la colse così, silenziosa e lieve: la ricoprì soffice come schiuma, ma inarrestabile, decisa, abbondante. Sfiorò i suoi sci confitti verticali a due metri dal suo corpo disteso, che in un attimo fu cancellato, nascosto al cielo. Dal basso gli sciatori sulla pista la videro arrivare: tanta neve che franava su se stessa, imprevedibile e inarrestabile come una malattia; come una malattia muta e subdola. Non fu un rumore ad accompagnarla, piuttosto il rombo del silenzio che si amplifica, e diventa eco del nulla. Subito dopo fu il caos, uno spingersi di giovani terrorizzati fino allo spiazzo che si apre davanti all’hotel, là dove si riuniscono le piste e si radunano gli allievi della scuola di sci. Sciamavano impazziti, rincorrendosi e urlando, mescolandosi nei colori e nei gesti, «la valanga, la valanga!».
Non appena fu tornata un po’ di calma, un omone in nero dai baffi spioventi ansimò a voce grossa e implorante: «Ce sta ’na ragazza là sotto, l’ho vista co’ miei occhi, s’era fermata a riposa’…». E a chi gli si affollava intorno ripeteva che era una ragazza alta e magra, giovane, con una giacca a vento verde, faceva fondo, era salita con lui sullo skilift e poi era uscita fuori pista e poi e poi… Come l’avesse aspettata tutto il pomeriggio, di ritorno da quella sua gita solitaria e coraggiosa, e ritrovatala che usciva dal bosco, non le avesse mai tolto gli occhi di dosso… «Annamo, annamo a cercalla…» Partirono in un primo gruppo di quattro, due guide alpine, un medico e l’omone in nero, mentre scattavano le operazioni di soccorso e si dava l’allarme in tutta la zona. Ci misero poco più di mezz’ora a raggiungere il luogo in cui la ragazza era stata vista per l’ultima volta, e iniziarono subito a scavare con le pale che si erano trascinati dietro, su una slitta. Avevano, come punto di riferimento per la ricerca del corpo, gli sci che sporgevano ancora dall’ammasso di neve fresca per circa quaranta centimetri.
L’uomo dal cappuccio di pelo non riusciva ad essere preciso, con le sue indicazioni: ripeteva che la ragazza si era distesa a qualche passo dagli sci, ma non ricordava se a destra o a sinistra, più in alto o più in basso. A coprirla, non doveva esserci che un metro di neve: era – lo ricordava bene il romano – completamente sdraiata. Infilavano sonde, a cercare una resistenza. Appena intuivano un ostacolo, prendevano a spalare con ostinazione, e rabbia. «Non te la sarai mica sognata, questa fondista alta e magra?» «E gli sci? Che ci farebbero qui gli sci? L’ho vista bbene; scava, scava, che dev’essere qui sotto, poraccia…».
Fu la guida più giovane a urlare, dopo quasi un’ora che erano lì, che sotto il piede si era ritrovato un lembo di giacca verde, e a fare segnali, che stava arrivando il grosso dei soccorsi, coi cani, e dovevano sbrigarsi. «Fa vede’… È lei, è lei!», l’omone sempre più agitato e ansimante, al punto che il medico era stato tentato di allontanarlo da lì. Riuscirono in poco tempo ad estrarre gli scarponi, uno vicino all’altro quasi la ragazza li avesse appena sfilati dai piedi. Quindi, subito dopo, dei calzoni scuri, con le bretelle. «E che, s’era tolta la tuta?» Qualcuno ridacchiò. Il romano sosteneva che probabilmente quelli erano indumenti di ricambio rovesciatisi dallo zaino. «Si muove qualcosa, qui. È viva!» Il medico chiedeva di essere il primo lui, a tirarla fuori, schiodando una falda della giacca da una lastra di ghiaccio. «Ma dov’è?» Sembrava essere sprofondata giù nella neve, essersi sciolta in essa.
Fu un guizzo, e una lepre alpina sbucò fuori dalla giacca verde finalmente liberata dalla morsa del ghiaccio, stretta nelle mani di un soccorritore. Prese a correre leggera e spaventata, tra tanta gente, verso il bosco e l’alto della montagna, ormai in ombra.
(1990)
In Fine dicembre, Le Onde, Chianciano Terme 2010, in Inverni e primavere, (e-book) 2016 e in Gli Stati Generali, 16 dicembre 2021
LA MOSCA
Adesso sembra che li chiamino per nome, e quindi Guendalina Matteo Vanessa (più nessuna Maria) i bambini nelle prime elementari, o con i diminutivi addirittura: Michi, Checca. Io invece (mi è accaduto sempre, anche da grande) sobbalzavo, tremacchiavo gambe e cuore quando chioccia la suora dall’alto (curva e nera corvaccia, avvoltoia col velo) dalla cattedra in alto ai miei occhi, mi strideva il cognome allungandone le “i”, impietrandone il gi-acca.
Puntuale mi pungeva il cognome a me estraneo ma mio, come la gonna o i calzettoni me l’avevano messo addosso (nemmeno comperato), proprio naturale come la pelle ma proprio indifferente come la pelle. E perciò in esso io dovevo riconoscermi, così severo e persino plurale, come se invece che una fossimo tanti a rispondergli in quella classe. Però io a quello stridio di vocali a quella difficoltà di dittonghi dovevo alzare la testa rispondere – sì? –, dovevo arrossire avvicinarmi silenziosa: a me si riferiva quel cognome, e per primo sempre all’appello agucchiante, spilloso squarciava il silenzio.
Dunque un giorno ritmato da un battito di mani più che mai esplose istrione e fatato a cogliermi in fallo a sbattermi le ciglia a fingere una gomma una matita cui potermi aggrappare: il cognome mio. Mi chiamavano gli occhi dei bambini poco complici alcuni divertiti a tornare tra loro da chissà quali paradisi. Non ero attenta diceva la suora, spiegava a tutti che guardavo il vuoto, mi umiliava, dovendo invece – e lo capisco adesso – esserne lei umiliata. Eppure io vergognosa tentavo da bambina di fare la pace piegavo la testa mi mentivo pentita: però non mi usciva di bocca a che cosa pensavo, già giravano gli occhi ispirati in cerca di bugie che supplissero la vera ragione; a che cosa pensavo davvero non l’avrei mai e poi mai detto. Forse – tento – pensavo al compito, ma non convincente abbastanza lei dice che guardavo nell’aria qualcosa.Forse allora cercavo una mosca.
La risata infantile fa ridere, come un fiume che scende alle spalle e davanti ridono i bambini a me accanto di lato per tutta la classe, e la suora come le si piega il labbro come (per poco ma chiaro) le trema il mento. Triste non potere abbandonarsi, per il duplice compito di educatrice e di religiosa: si tratteneva la maestra, non rideva con gli altri se pure ne aveva voglia. Anch’io sorridevo sollevata, per simpatia a quella improvvisa allegria che io stessa avevo sfrenato e del tutto involontaria inconsapevole, anch’io, mi sembrava di essere acuta e spiritosa perché – forse cercavo una mosca – era infatti una bella risposta.
Quando poi si calmarono tutti si riprese il filo del discorso interrotto di prima, tornò la suora a spiegare monotona, la bambina che ero ancora radiosa e protagonista della mattinata mi venne in mente che per niente li avevo divertiti. Che delusione se avessero saputo che sul serio cercavo una mosca, ascoltavo sospesa se per caso un ronzio si sentisse tra i banchi o di dietro le tende; io quel giorno realmente avevo appuntamento con una mosca. Come infatti avrei potuto mentire su un tale segreto, come anche però rivelarlo senza sentirmi ferita nella mia ingenuità certo poi presa in giro, schernita. Non potevo raccontare che io avevo una madre così differente dalla suora corvaccia così insomma bella che quasi innamorata ogni mattina mi spiaceva lasciarla e andare a scuola; non certo potevo dire che una promessa ci legava, me e lei che portavamo lo stesso cognome, che insieme magari ci pensavamo distratte. A me sua bambina lei assicurava che un giorno diventata mosca o farfallina o altro piccolo insetto si sarebbe introdotta nella classe a spiarmi a girarmi intorno alla penna o sul quaderno appoggiandosi, io piano le avrei detto: ciao! riconoscendola. Lei venuta a salutarmi per cogliere di me momenti che non conosceva, lei poteva da mosca non lasciarmi, seguirmi piccolissima. E io ciao o altra importantissima cosa le avrei rivelato, che mi annoiavo che mi portasse a casa.
Cercavo davvero una mosca quella mattina, davvero al mio cognome così forte urlato avevo temuto che una mosca da qualche parte nascosta avesse potuto sentire, magari dissentire.
(1977)
In Appuntamento con una mosca, Stamperia dell’Arancio, San Benedetto del Tronto 1991, e in Inverni e primavere (e-book) 2016
LETTERA A UN UOMO DEL FUTURO
L’uomo del futuro sarà una donna, sarà una ragazza, sarà una vecchia: avrà un colore biscotto, color avana, capelli neri e ricci, capelli bianchi e crespi. Si chiamerà Axa, o Niobe, o Bela; si chiamerà Maria. Avrà diciassette anni nel duemilaquarantanove, sarà la nipote di mia nipote, sessantenne nel duemilaottantatré, nonna di bambini sconosciuti.
Come camminerai spavalda e tesa, sicura della tua bellezza tranquilla, mia ragazza del futuro, figlia di mia figlia di mia figlia: come andrai incontro al tuo amore sospeso tra idea e carne, tra timore e desiderio. Con quali parole gli dirai il tuo bene, parole antichissime e nuove di lingua straniera, e come per poco ti tremerà la mano nella sua, come premerai il seno giovane sulla sua giacca. Gli dirai cose belle, lo bacerai sulla bocca come hanno fatto tutte le donne del mondo da sempre, ma voi nuovi e per sempre: unica la tua voce, che si perderà nell’aria altissima, lontana negli spazi; uniche le parole che tu sola avrai inventato con il tuo accento, con il timbro speciale di un suono che cresce.
Le ho dette anch’io le stesse parole, le mie, che rimarranno identiche e diverse: le ha dette la nonna che sarai, uguale e differente da te. Eccola seduta nel parco a leggere un libro, e inforca gli occhiali e li toglie e li rimette. Guarda i bambini intorno, i vecchi come lei; cerca nelle facce segnate le rughe dell’uomo che ha amato di più e lo pensa e lo pensa. I suoi pensieri rincorreranno i tuoi, ragazza del duemilacinquanta, faranno loro compagnia. Si intrecceranno, i pensieri di tutti, i miei passati, i tuoi vivi vivaci, quelli di chi verrà e non lo sa ancora. Godi ogni momento, Bela Niobe Axa, non essere indifferente a nulla, ragazzina dai capelli neri e ricci che avrai già visto tante cose, pensato tante cose. Controlla ogni passo che farai, che si appoggi consapevole al selciato, cosciente del cammino che compie – di qua, di là – e vola, e alzati sempre, in alto in alto; mia cara.
Dai a lui tutte le carezze che puoi perché non saranno sprecate, dagli il bene che sai e non pentirtene: ma poi torna in te, torna a te, recupera il tuo attimo, quello tuo solo tuo, segnalo della tua impronta, non lasciarlo sospeso e anonimo. Vai leggera verso casa, sali al tuo appartamento che non so immaginare, saluta chi ti è vicino e non so immaginare. Poi entra nella tua stanza a ripensarti il giorno che hai vissuto, affacciati al balcone e guarda quello che è sotto ed è di tutti. Fallo tuo col tuo sguardo; la gente colorata, l’erba verde, le montagne bianche sullo sfondo. Parla ai gerani che innaffi, aiutali a crescere con le tue attenzioni, e poi pàssati una mano tra i capelli, prova a cantare una canzone di moda. Fai ciao con la mano a chi guarda in su, regala la tua bellezza e i tuoi pochi anni a quelli che distratti ti passano accanto, non si accorgono di te o se ne accorgono in ritardo, e gli dispiace. Perché ci sei, per fortuna, esisti, miracolo che potevi non esserci. E invece eccoti qui, ragazza; ci sei perché c’è stata tua madre, tuo nonno, una amore, una scimmia, una violenza. Ci sei e potevi non essere, sarebbe bastato un gesto, un ritardo a un appuntamento, una leggera antipatia. Invece sei la parola benedetta, sesamo che ha schiuso una possibilità: futuro mio, di chi ti ha voluto, e del mondo impassibile. Ci sei Niobe, ci sei Maria coi capelli bianchi e coi denti finti, tutti uguali e perfetti, sorriso che teme il rifiuto dell’universo. Ma spegni il video, nonna, spegni la radio che suggerisce sciocchezze per incantarti, ed esci, vai fuori a trovare la gente, parla a chi non conosci. Diranno di te che sei strana e svampita, diranno che sei matta. Ma tu continua imperterrita, mia nonna del futuro, mia antica Maria dai capelli bianchi e crespi. Racconta a chi ti siede vicino la vita che hai fatto, e come hai lottato contro la stupidità, la paura del giudizio altrui.
Parla di quella volta che ti hanno licenziato dall’ufficio perché te ne eri uscita prima, senza dare una spiegazione, senza chiedere un permesso, e al capo indignato stupefatto avevi risposto serafica: «Così, non so perché l’ho fatto, era una bella giornata, avevo voglia di camminare guardando i negozi…»; oppure di quando hai annunciato a tuo marito che eri incinta, che vi sarebbe nato un figlio, e lui ti ha risposto: «Davvero? Ma dici davvero? Davvero?», e non sapeva dire altro, non sapeva fare altro. Di’ pure che hai amato, che hai patito: non sei stata avara di sentimenti e di saluti, senza occuparti del percento di resto, di quanto ti veniva restituito. Vantati di aver imparato l’ebraico a cinquantadue anni per poter leggere l’Ecclesiaste, racconta che suoni il liuto anche adesso che le mani ti tremano: fai le scale, esercizi, solfeggi. E tutto questo non serve a niente, a nessun altro che a te. «Perché lo fai? – ti chiedono – Perché è bello», rispondi.
Loro, che rimangano nei loro uffici ordinatissimi, che ballino nelle loro discoteche abbagliate, che si vestano firmati dal niente, occupando tronfi cervelli abitati da idee altrui. Sprechino i loro sonni in conticini assurdi, dove investire dove disinvestire; si divertano a comando, tutti insieme, hop! hop! hop!, a facciano l’amore su ricetta, il giovedì e la domenica sera.
Ma tu, antica donna del futuro, matriarca santissima, salvati adesso e ancora, perché ti sei già salvata la vita con tutta la tua vita di prima; sii diversa e libera il mondo dal male, il pezzetto di mondo che conosci, esorcizzalo, guariscilo. Alzati dalla panchina dove sei seduta, metti via il libro che stavi leggendo, rassettati la gonna a pieghe, fai scivolare la mano sui capelli bianchi, che tu sia tutta a posto e bella a vedersi per chi ti passa vicino, cammina dritta guardando negli occhi la gente, antica Maria benedetta, attraversa il parco lentamente e sicura. Poi, quando sarai arrivata sul viale, alza la faccia e osserva che c’è una ragazza al balcone di un palazzo giallino. Vedi com’è color biscotto e che capelli ricci e neri ha, forse si chiama Axe o Niobe o Bela, sta annaffiando gerani rossi che scendono fitti nel verde e allegri, probabilmente canta. Falle un cenno con la mano, a quella ragazza del futuro che adesso ti guarda e ti fa ciao e sorride. È tua nipote, è tua figlia, sei tu quando avevi diciassette anni. Come sei cresciuta e invecchiata, come sei giovane ed eterna.
Salute, donne del futuro, uguali e diverse; vi siete incontrate di nuovo, per caso, per necessità; sarete un’unica cosa quando non ci sarete più, sarete il tutto, sarete il niente che verrà.
In Qualcosa del genere, Italic Pequod, Ancona 2018
LUI E LORO
Sapevo benissimo che a loro non piaceva che mi sedessi lì, sul muretto – in realtà poco più di un gradino – ad aspettare l’uscita degli operai. Avrebbero preferito che seguissi sorelle e cugini giù nei campi, a correre, a slittare dentro scatole di cartone per i pendii del prato. Ma dopo un po’ quel sudare e quell’urlare mi fiaccava, era del tutto sprecato, visto poi che nelle gare arrivavo quasi sempre seconda o terza, alta com’ero. Mi facevo vincere addirittura dalla sorella più piccola. Allora andavo a sedermi sul muretto, e mi cullavo dondolando la schiena appoggiata alla rete metallica, completamente arrugginita e qua e là bucata: che guai a graffiarcisi la pelle, veniva il tetano. Ogni tanto alzavo gli occhi alla finestra temendo di incontrare altri occhi accusatori – Cosa fai lì? –, ma a quell’ora le donne di casa erano in genere affaccendate intorno alla cucina, e comunque avevo giù pronta la risposta – Aspetto papà –, una specie di formula magica, capace di assolvere e di procurare benedizioni.
Mancava poco a mezzogiorno, spiavo l’enorme orologio della portineria caricato dall’enorme portinaio Stefani. Se lui mi vedeva ed era in buona, lo sapevo capace di chiamarmi dentro a schiacciare il bottone della sirena, a mezzogiorno in punto. La sirena della cartiera si sentiva in tutto il paese: che il mio dito producesse un tale prodigio, e la gente, su mio comando, smettesse il lavoro, preparasse la tavola, mi esaltava. Perciò speravo sempre che Stefani mi chiamasse anche se poi la mia sirena usciva stentata, fioca e brevissima. Il dito mi si spaventava presto: al primo alzarsi del mugolio, all’esplodere acuto del suono, io ritiravo la mano, timorosa di aver osato troppo. «Macca, macca», mi incoraggiava Stefani, per poi, sbuffando, maccare lui. Che sirena potente, invece, sapevano fare gli altri bambini. Mio cugino la faceva durare più di un minuto, e a volte la suonava anche di nascosto, fuori orario. Mezzogiorno produceva il miracolo di animare le strade, piene di tute blu e di sparsi grembiuli neri, di donne e uomini in bicicletta, che improvvisamente uscivano dai cancelli della fabbrica, chiamandosi, ridendo. Io sedevo lì a contemplarli, e li conoscevo tutti di faccia. A qualcuno avevamo anche affibbiato un soprannome: “ondina”, l’operaio dai capelli ricci; “placido”, quello che pedalava sbadigliando; e “sorriso”, la vecchia con un dente sì e uno no. Li guardavo contenta per loro, che avessero finito il turno, ma non mi sembravano felici come noi all’uscita dalla scuola. Non si precipitavano sulle loro bici, a volte si fermavano a discutere, a volte distribuivano volantini che subito andavo a recuperare, se qualcuno li buttava per terra. Li leggevo capendoci poco, ma istintivamente sentendo che avevano ragione, con quei NO!, quei MAI! e LOTTIAMO! Mah, erano forse così seri per quei fogli che mio padre accartocciava nervoso quando glieli mostravo: lui e loro spesso non andavano d’accordo.
Molti operai però non tornavano a casa a mangiare, rimanevano nel refettorio: erano quelli che abitavano lontano, o quelli che avevano il turno dopo pranzo. Quando era bel tempo, uscivano col pentolino, si sedevano sui gradini, sul muretto, anche sull’erba, e pranzavano lì. Io stavo immobile tra due di loro, parlavano sempre in dialetto, e non capivo. Ma guardavo quello che mangiavano, come facevano scattare la serratura dei loro tegami e ne uscivano profumi e sapori diversi, tutti mescolati con l’odore che avevano addosso, sulle mani: di ferro, di unto. Sarebbe piaciuto anche a me poter mangiare fuori, avere un pentolino così, bere dalla bottiglia. Mi sembrava godessero di più il cibo, masticando a bocca aperta come facevano. Uno di loro, tra i più anziani, veniva a sedersi apposta vicino a me, e io lo temevo perché sapevo che inevitabilmente mi avrebbe parlato della sua bambina, confrontandola con me, con quello che sapevo e che – soprattutto – non sapevo. Mi chiedeva cosa stavamo facendo a scuola, mi interrogava sulle tabelline, concludendo sempre che la Mariarosa era più avanti. Era più alta, più robusta, coi capelli più lunghi e ondulati. Cercavo di sfuggirlo, il papà della Mariarosa, ma lui mi scovava mimetizzata tra gli operai, e mi raggiungeva ovunque. Per questo, aspettavo l’uscita di mio padre dalla fabbrica come una liberazione.
Lui era così diverso da loro. Così elegante. Aveva la camicia bianca, una cravatta, i polsini con preziosi “gemelli”, che ahi!, se li toccavamo, noi bambine: li sapeva chiudere solo mia madre. Aveva una cartella nera, di pelle. Usava un dopobarba che lasciava un buon profumo nella stanza, anch’io me lo mettevo dietro le orecchie. Mio papà era dirigente. Quando a scuola la maestra ci aveva chiesto, a tutte, il mestiere del padre, tra tante che avevano risposto impiegato, dottore, tecnico, colonnello, io sola avevo potuto vantarmi: “dirigente”. Come dire, uno che dirige, più che direttore, insomma il più importante. Infatti tutte si erano voltate a guardarmi, forse non sapendo nemmeno cosa significasse. Così io aggiungevo che era quasi come presidente, e la rima bastava a persuaderle. Non avrei mai potuto confessare, però, che era anche liberale; dirigente e liberale, nella mia grammatica l’aggettivo veniva a lordare il sostantivo. Forse i “moti liberali” del 1821 studiati a scuola mi avevano convinta dell’equazione liberale=rivoluzionario. Ma più probabilmente era stata la lezione di catechismo in cui la suora ci aveva illustrato i pericoli derivanti dal non votare la croce, pericoli che il vero cristiano deve sfuggire. Da allora, nelle mie preghiere serali supplicavo Dio che liberale non significasse almeno comunista, che mio padre venisse illuminato da una grazia particolare. Tutto il parentado, compresa la cameriera che era un po’ innamorata di mio papà, votava PLI influenzato da lui: ma ciò non mi era di conforto, anzi aumentava il mio tormento.
Quando mio papà dirigente usciva dai cancelli della fabbrica, mi sembrava che gli operai parlassero più piano. Qualcuno a volte lo fermava, andava a discutere. Io temevo che gli urlasse contro qualcosa, ero sempre un po’ sospesa. Lui spesso non si accorgeva nemmeno che c’ero, non mi vedeva tra tutti quegli uomini: che, come loro, lo temevo un po’, ma diversamente da loro, lo aspettavo con un tremore tutto mio, con lo sguardo più fedele e indulgente del mondo. Ma lui faceva di corsa i tre gradini che lo separavano dall’ingresso di casa, pensieroso per chissà quali preoccupazioni. Io rimanevo male, lo guardavo sparire nel buio del portone, e mai avrei osato chiamarlo, trattenuta dal doppio timore di interrompere le sue meditazioni e di attirare su di me l’attenzione severa degli operai. Aspettavo qualche minuto, che nessuno pensasse più a lui: poi mi alzavo, e con calma, con simulata indifferenza, entravo anch’io in casa, senza riuscire però a raggiungerlo per le scale. Quando invece capitava che mi vedesse con la coda dell’occhio, che pendevo da un suo gesto come un cagnetto, allora quel gesto lo faceva. Alzava un po’ il braccio sinistro e muoveva le dita per invitarmi a dargli la mano. Rimaneva fermo, gli si muovevano solo le mascelle in un suo tipico vezzo di quando aveva fretta: ma mi incoraggiava a raggiungerlo. Scattavo velocissima, volavo: infilavo la mia mano piccola nella sua così grande, e salivo voltando le spalle ai miei amici operai. Non parlavamo, non lo guardavo in faccia, tutt’al più tenevo gli occhi sui suoi polsini, sui suoi gemelli. Lui non mi chiedeva mai le tabelline, perché era dirigente e aveva molto da fare. Era elegante, era bello, sapeva stringere le mascelle, muovere le dita, impartire ordini. Ma a me si stringeva il cuore, se mi raggiungeva alle spalle il succhiare degli operai nei loro cucchiai, o qualche rutto; sentivo come una vergogna e non sapevo perché.
(1984)
In Appuntamento con una mosca, Stamperia dell’Arancio, San Benedetto del Tronto 1991 e in Inverni e primavere (e-book) 2016
MICROBI, BATTERI, SPORE VIRALI
Il mio ragazzo, il mio Davide, è sempre stato un po’ particolare. Già da piccolo alternava momenti di immotivata euforia ad altri di ostile mutismo. Improvvisamente, diventava preda di una collera furiosa, e allora si scagliava con violenza contro tutto ciò che gli stava intorno: persone e oggetti. Altre volte si addolciva in una mansuetudine addirittura eccessiva, e per noi preoccupante, quasi a voler meritare la grazia di un perdono o di una ricompensa celeste. Capace di cambiare atteggiamento e natura nel giro di una sola ora, angelico e spietato. Ci eravamo rassegnati, io e suo padre, a questa mutevolezza ombrosa del suo carattere, che non esprimeva solo tra le mura domestiche, bensì anche a scuola, provocando sospetto e disappunto tra i compagni e negli insegnanti. I suoi bizzarri comportamenti infantili venivano giustificati da parenti e amici come effetto di un’educazione troppo arrendevole e indulgente da parte di noi genitori, che probabilmente avevamo esagerato nel viziarlo.
Comunque, lo stato di salute di Davide è rimasto gestibile fino alla preadolescenza. Intorno agli undici anni successe però qualcosa che gli stravolse i pensieri; un cortocircuito mentale, un’affezione emotiva paragonabile a uno sconquasso tellurico. Ero in cucina, preparavo gli agnolotti al ragù per la gioia di mio marito, in attesa del suo rientro dall’ufficio. Sentii un urlo arrivare dal bagno, e il mio bambino singhiozzare chiamandomi “mamma, mamma!” Mi precipitai da lui, e lo trovai seduto sul water, con i pantaloni della tuta calati sui piedi, il rotolo della carta igienica tra le mani tremanti, a riparargli gli occhi da una visione terrificante. Lo abbracciai tenendogli la testa appoggiata al mio ventre, come sempre facevo durante le sue crisi di rabbia. “Dido, tato, tesoro mio, cosa succede?” Scosso da acuti singulti, balbettava “schifo, schifo”, e poi “c’è il sangue, sangue bagnato”. Mi guardai intorno, pensando a un’allucinazione. Scorsi, semiarrotolato nel bidet, un mio assorbente macchiato di rosso, che avevo dimenticato di sigillare come sempre nella bustina di plastica opaca, gettandolo nell’immondizia. “Dio mio, cos’ho fatto!” pensai, conoscendo la fobia di mio figlio per qualsiasi traccia di secrezione fisica: muco nasale, saliva, orina, feci. Sangue, appunto. “Non è niente, caro. Non è proprio niente. Sono cose della tua mamma”, cercai di tranquillizzarlo. La sua disperazione aumentò. “Ti sei fatta male? Dove ti sei fatta male?” Piangeva inconsolabile. “Stai per morire? Devi andare all’ospedale?” Non ricordo come mi riuscì di calmarlo, raccontandogli quale bugia. Forse, che mi ero tagliata distrattamente un dito pulendo la verdura.
Non avevo mai parlato con Davide di sessualità, pensavo fosse un compito della scuola, oppure se ne dovesse incaricare mio marito. Gli avevo spiegato a grandi linee come nascono i bambini, senza addentrarmi nei particolari, e suscitando in lui un vago disgusto. Non gli avevo neppure mai accennato alle mestruazioni, e quando mi capitava di soffrire durante il ciclo, alludevo genericamente a un malessere passeggero. Ma da quel giorno, alla vista del sangue, anche solo in un film o riprodotto in un quadro, il mio ragazzo esibiva reazioni spropositate: nausea, tremori, attacchi di panico. Cominciò a prestare più attenzione alla pulizia personale, cosa insolita in un adolescente: si faceva la doccia appena sveglio e prima di coricarsi la sera, si lavava le mani in continuazione, e se la schiuma mista all’acqua gli sembrava appena un po’ grigiastra, mi chiamava a testimone: “Vedi quanti microbi, mamma? Bisogna distruggerli, i microbi…” Osservava minuziosamente la superficie dei mobili, se per caso si fosse depositata un po’ di polvere, e mi rimproverava: “Devi pulire di più, devi disinfettare i pavimenti, devi aggiungere la candeggina in lavatrice!”
La vita in casa nostra era diventata un incubo, e mio marito non riusciva a nascondere esasperati moti di stizza. Lo supplicavo di portare pazienza, di essere più comprensivo e affettuoso, ripetendogli che nostro figlio stava attraversando una fase complicata della crescita, ma senz’altro transitoria, come mi aveva assicurato il nostro medico di base.
Il fatto è che Davide, per suffragare scientificamente le sue teorie, aveva iniziato molto presto a consultare in internet testi di microbiologia, di virologia e di epidemiologia, sentendosi poi autorizzato a erudirci sulle cognizioni acquisite. I microbi, da cui era ossessionato, vennero ufficialmente riclassificati: “batteri, microrganismi unicellulari onnipresenti ovunque: nel cibo, nell’aria, nell’acqua, nei nostri corpi; batteri da cui tre miliardi di anni fa è nata la vita sulla terra, batteri che distruggeranno il genere umano, più potenti e letali di qualsiasi bomba atomica…”
Terminata con voti discreti la scuola media, ci sembrò scontata la sua richiesta di iscriversi all’Itis di biotecnologie sanitarie, un istituto privato innovativo, tenuto in grande considerazione nella nostra città. Mio marito fece presente al preside la particolare patologia di cui soffriva il ragazzo, una sorta di ipocondria che uno specialista aveva definito oscillante tra misofobia e rupofobia. Termini per noi astrusi, ma di cui diventammo subito molto competenti: paura delle malattie, delle infezioni, dello sporco, che costringe chi ne è affetto a mettere in atto riti di protezione morbosi e maniacali.
Fu garantita a Davide una particolare attenzione da parte del corpo insegnante, il permesso di occupare un banco da solo, di uscire spesso per recarsi al bagno, di sterilizzare con salviettine igienizzanti gli oggetti con cui entrava in contatto, e soprattutto di assentarsi dalle lezioni. Infatti i suoi disturbi lo costringevano a rimanere frequentemente a casa, in preda a tremiti, vomito, febbriciattole. Si chiudeva nella sua stanza, tappezzata da manifesti riproducenti vari tipi di virus, bacilli, cocchi, vibrioni, spore, procarioti (a bastoncino, a spirale, a grappolo, a catena, sferici, cubici), che io tentavo vanamente di imprimermi nella memoria, sperando in qualche modo di trovare la chiave per penetrare nel cervello di mio figlio. Stava lì, sdraiato sul letto, a contemplarli con lo sguardo fisso alla parete; oppure li riproduceva a matita su un quadernone, e poi li colorava con notevole estro artistico. Poi, per ore, rimaneva incollato al computer, a consultare Wikipedia o chissà quali altri manuali di medicina. Mi consolava il pensiero che, una volta uscito dal tunnel delle sue fissazioni, sarebbe potuto diventare un ricercatore universitario, un luminare di qualche branca scientifica, un biologo di fama.
La giovane psicoterapeuta che lo aveva in cura ci aveva esortato ad applicare nella nostra quotidianità alcune tecniche adattive, per indurlo gradualmente ad accettare minime tracce di contaminazione (negli oggetti di cui si serviva, nei vestiti, nell’arredamento), sottraendole a ogni temuta nocività. Seguendo le indicazioni della dottoressa, lasciavo apposta una forchetta incrostata tra le posate, dimenticavo di azionare lo sciacquone del water, non cambiavo i calzini e non lucidavo le scarpe. Ero arrivata addirittura a nascondere qualche capello nei cibi che cucinavo. Lui rispondeva ai nostri impacciati esperimenti in maniera sempre più violenta; sembrava quasi godesse sadicamente nel provocarci, per vedere quanto a lungo avremmo ancora sopportato la sua nevrosi.
Il primo a cedere fu mio marito. Stavamo pranzando, e Davide allontanava con la mano alcune briciole di pane sparse sulla tovaglia, pretendendo come sempre che lo spazio intorno al suo piatto rimanesse sgombro e immacolato. Rivolto a suo padre sentenziò: “Non è bello lasciare la mollica sulla tovaglia”. Poi alzò il bicchiere per osservare controluce se fosse pulito. “I germi si annidano dappertutto. Dobbiamo usare tutte le precauzioni per non ammalarci”. Parlava a slogan, come dovesse convincere un pubblico di analfabeti.
“Ti sei lavato le mani, papà? Ci si deve insaponare bene le mani, prima di mettersi a tavola”. Mio marito lo guardò severo, poi si alzò, si diresse verso il lavandino, aprì lo sportello della pattumiera e sollevò il secchio.
In silenzio, solennemente, rovesciò l’immondizia addosso a nostro figlio. Davide balzò in piedi. Aveva le spalle coperte di fondi di caffè e di bucce d’arancia, e un liquido giallognolo gli colava sulla fronte. Spalancò la bocca per gridare, ma non gli uscì mezza parola.
Suo padre gli piantò una manata tra le costole. “Eccoli, sono tutti tuoi: microbi, batteri e schifezze di casa nostra”. Poi prese la caraffa dell’acqua e gliela versò con imperturbabile lentezza in testa. “Adesso lavati, idiota”, proferì spietato e soddisfatto.
«Gli Stati Generali», 25 novembre 2020 e in «Gente normale», Eretica 2024.
NON SAPEVA COME DIRMELO
Se lo sono sempre chiesti tutti, come mai uno come lui si interessasse a una come me. Sì, perché lui era un bel ragazzo, davvero bello. Alto, con un fisico asciutto, capelli castani e folti, e un viso espressivo, un po’ irregolare forse, ma proprio per questo più attraente. Occhi marroni, anzi nocciola, con pagliuzze dorate nell’iride, e soprattutto un sorriso dolcissimo. Non femmineo o affettato, ma indulgente, affettuoso: così ce l’hanno solo le persone che capiscono gli altri, e non giudicano. Anche il suo nome era gentile: si chiamava Giuliano.
Io invece, esattamente il contrario. Bassa e robusta, con braccia e gambe muscolose, frangetta nera, occhiali di corno, bocca larga. Severa e rabbuiata, maschia come forse mi desiderava mio padre, che sperava in un Ernesto. Ernesta, appunto.
Però tanto intelligente, caparbia nello studio, e ambiziosa. Stessa classe al liceo, stessa facoltà di medicina. Amici, colleghi, anche un po’ rivali, noi due: Ernesta e Giuliano. Per quale motivo avessimo finito per fidanzarci, e poi per sposarci, questo restava un mistero per chiunque ci conoscesse. Amore? Mah. Ne dubito. Certo, la nostra relazione mi inorgogliva, però sentendomi tanto inferiore a lui fisicamente, continuavo a dubitare dei suoi sentimenti, e a interrogare i miei. Simpatia? Troppo diversi nel carattere e nelle opinioni sul mondo, per piacerci a vicenda. Allora cosa? Be’, credo che ci fossimo scelti reciprocamente per esclusione, cioè depennando una alla volta ogni eventuale proposta alternativa.
“Esco”, dopo cena, mentre sfogliavo una rivista in salotto. “Ancora? Sei già uscito l’altra sera, e hai fatto tardi”. Si comportava in maniera strana, da qualche mese. Silenzi improvvisi, sguardo perso nel vuoto, sbalzi di umore. Dall’allegria immotivata alla malinconia più grigia. Irritandosi per qualsiasi sciocchezza, anche con gli oggetti che gli sfuggivano di mano, con le previsioni del tempo sballate, con le notizie dei giornali. E non mi regalava più i suoi sorrisi teneri, disarmanti. Poi queste uscite serali, almeno due volte la settimana. Incontri professionali, mi aveva detto. Voleva cambiare lavoro.
Aveva già lasciato tre ospedali, nei nostri venticinque anni di matrimonio. Ora, sembrava avesse trovato l’ambiente giusto in una clinica privata della provincia, a una trentina di chilometri da casa. L’equipe con cui collaborava, le mansioni che gli erano state affidate, lo stipendio più che dignitoso sembrava lo ripagassero della lontananza e del traffico stradale contro cui lottava quotidianamente. Si era specializzato in radiologia, io invece in oculistica. Nonostante il mio proclamato ateismo ero rimasta sempre fedele al Sacro Cuore di Gesù, diventando vice primario, e un punto di riferimento anche politico per la sanità cittadina.
Non abbiamo avuto figli, per scelta e per destino. Da subito avevamo ritenuto opportuno dedicarci totalmente alla nostra professione, e inoltre nessuno di noi risultava particolarmente sensibile al richiamo dei sensi, appagati per quel tanto che si ritiene necessario. Tornavamo stanchi e stressati dal lavoro in corsia e in ambulatorio, e spesso dovevamo seguire corsi di aggiornamento, partecipare a congressi, approfondire ricerche: ciascuno per conto suo, senza rendere conto all’altro. Anche così, tuttavia, in questa semi-estraneità reciproca, continuavamo a ritenerci una coppia affiatata, senza eccessivi problemi.
Ma adesso, dopo tanto tempo, questa strana e improvvisa reticenza di lui, l’imbarazzato fastidio se appena osavo domandargli qualcosa della sua giornata in clinica, mi mettevano in allarme. Mi addolorava, insomma, vederlo turbato. Sapevo di un forte contrasto nato mesi prima con un collega chirurgo, Brioschi mi sembra si chiamasse, riguardo all’interpretazione di alcune radiografie, dopo un intervento ai polmoni in un giovane paziente. Mi aveva raccontato di uno stillicidio di battute e allusioni offensive che questo dottore gli riservava a ogni incontro, in privato e in pubblico. E di un violento alterco nel bar della clinica. Cosa che mi riusciva difficile da immaginare, conoscendo la mitezza di mio marito, il suo disappunto di fronte a qualsiasi smodata esternazione verbale.
“Cosa cerchi?”, gli avevo chiesto una settimana fa, trovandolo inginocchiato per terra a frugare nell’ultimo cassetto della scrivania. “Ah, niente. Metto in ordine le mie carte”. “Sei proprio deciso a cambiare? Forse dovresti consultarti con la direzione, prima”. “Ma no, sarebbe inutile. È una questione che devo decidere da solo”. Respirava a fatica, non si era nemmeno voltato a guardarmi in faccia. Poi era uscito, con un faldone di documenti sotto il braccio.
Per alcuni giorni lo osservai con particolare attenzione. Non dico lo spiassi, ma capitava che quasi istintivamente mi avvicinassi alla finestra per seguirlo con gli occhi, quando la mattina usciva di casa prima di me, si affrettava al parcheggio per prendere la macchina, metteva in moto e accelerava nervosamente in direzione della via provinciale. Chissà perché mi attraversavano la mente timori infondati, immagini di incidenti stradali, di alterchi con automobilisti aggressivi. Quasi fossi la mamma spaventata di un adolescente inaffidabile.
Dormivamo da alcuni anni in camere separate. Giuliano si lamentava del mio russare, io del suo agitarsi smanioso tra le coperte. Parlava spesso nel sonno, svegliandomi. Anche così, comunque, confinato nella cameretta degli ospiti, capitava lo sentissi mugugnare, o ridere, o lamentarsi spaventato da chissà che incubi.
“Smettila, Paolo, smettila!”, aveva urlato recentemente, continuando poi a mormorare parole incomprensibili, concitate. Sempre Brioschi, immaginai, il suo ossessivo fantasma persecutorio. Sì, mi sembrava si chiamasse proprio Paolo.
“Perché non ti prendi un congedo?”, gli avevo proposto. “Qualche settimana, un mese. Giusto per riposarti. Magari fai un viaggio, o vai al mare. Se ti allontani per un po’, ti tranquillizzi tu, e si rasserena l’ambiente al lavoro”. Aveva risposto con un gesto di insofferenza, alzando gli occhi al cielo. “Lo sai che hai ripreso a parlare, mentre dormi? E ti sento quando ti alzi e giri per casa…”. “Cosa fai, mi controlli? Ti do fastidio anche se respiro?” Era evidentemente esasperato, non sapevo se per colpa mia o di chi altro. Non voleva ne discutessimo.
Domenica mattina, a colazione, finalmente me l’ha detto: “Vado via”. Io ancora scema, ottusa, sconcertata, “Dove?”, gli ho chiesto. “Ho trovato un’altra sistemazione”. “Un altro ospedale? Una clinica privata?” Teneva gli occhi fissi sulla tazza del tè. “Mi hai nascosto qualcosa di grave, Giuliano? Quel tuo collega ti ha forse denunciato, Brioschi, o come si chiama, Paolo Brioschi?”. “Brioschi si chiama Pierpaolo”. “Va bene, chi se ne frega”. Mi tremavano le mani.
“Non vado via dalla clinica. Non ho dato le dimissioni”. Credo che mio marito non mi abbia mai rivolto uno sguardo così pieno di dolore. “Vado via da casa. Via da qui, da te”. Non capivo, non sapevo cosa rispondere. A me non sono mai mancate le parole, ma in quel momento non trovavo né voce né pensieri.
“Paolo, quel Paolo, è un altro”. Si era alzato da tavola. “Non sapevo come dirtelo”.
«Gli Stati Generali», 19 ottobre 2020 e in «Gente normale», Eretica 2024
NONNINO NONNINO
Mio padre è un uomo compito. Diversamente da me, che sono sempre un po’ arruffato, scomposto nel vestire e nel gestire, spavaldamente impetuoso nella parola, contorto nei pensieri: come tutti i timidi.
Lui no. Lui è sempre sobrio (anche se non ricercato) nell’abbigliamento, attento ad accostare con discrezione i colori: camicia e cravatta, pantaloni e calzini. È anche molto controllato nell’esprimersi, mai una bestemmia, una parolaccia. Riflessivo nei ragionamenti, gentile nel rapportarsi agli altri.
Un signore, insomma.
La cosa comica è che io insegno storia dell’arte nel liceo più glorioso della città, e lui ha sempre fatto il magazziniere in una fabbrica di calzature. Io posso vantarmi di una laurea e di un dottorato in estetica, lui ha il diploma di terza media. Io divoro libri di saggistica, sono appassionato di musica barocca, parlo correntemente inglese e tedesco. Lui è abbonato alla Settimana Enigmistica, ama i quiz televisivi e ascolta Radio Birikina.
Da quando mia moglie se ne è andata, lasciandomi le due bambine di tre e cinque anni, il mio buon papà ha generosamente deciso di trasferirsi nel nostro appartamento per aiutarmi nella cura della casa, e per occuparsi di Marta e Cecilia. Che lo adorano. Sospetto che vogliano più bene al nonno che a me.
Le mie figlie non chiedono mai della loro mamma, l’hanno cancellata da occhi bocca cuore. Con me si limitano a brevi comunicazioni di servizio, accendi spegni la luce, fa freddo fa caldo, ho fame ho sonno. Tutte le loro carezze, i baci, i gesti affettuosi sono per mio padre. “Nonnino nonnino”, lo chiamano. Cecilia, addirittura, è il suo ritratto, come se i suoi cromosomi avessero saltato una generazione. Stessi occhi azzurri, naso regolare, labbra un po’ piegate in giù, spalle strette.
Lui se ne compiace, gongola quando la osserva di nascosto e rivede sé stesso negli atteggiamenti composti e garbati di lei, per favore-permesso-grazie-scusa. Le accarezza i capelli biondi, e piano le sussurra “la mia bambina, la mia cara bambina”.
Quando torno da scuola, di pomeriggio, li vedo seduti sul divano. Complici, mano nella mano. Lui le legge un libro di fiabe, commentando le illustrazioni. Lei appoggia la sua testolina treenne al suo petto, e ascolta in silenzio, attenta. Spesso gli chiede di ripetere più volte la stessa frase, modulando la voce a seconda dei personaggi descritti. Lui obbedisce, paziente. “Nonnino nonnino”, irrompe in salotto la sorella più grande “Posso ascoltare anch’io?”. Spezza l’idillio, ma i due fidanzatini la accolgono comprensivi. Ecco edificato un allarmante triangolo, tra un maschio e due femmine rivali.
Io sono il quarto incomodo, l’escluso. Geloso? No di certo. Direi anzi, sollevato. Perché a essere sincero mi scoccerei proprio se ogni pomeriggio dovessi leggere una favola alle bimbe, dopo aver tentato di domare più classi di adolescenti, sciatti distratti arroganti.
“Nonnino nonnino”, già mi dà fastidio. “Papino papino”, non riuscirei a sopportarlo.
Loro lo sanno? Se ne accorgono? Ne soffrono? Non credo, troppo piccole, troppo occupate a succhiare ogni goccia di bene venga loro dispensata dall’avo.
Mio padre invece ha capito. Lo sa. E non gli dispiace avermi detronizzato. “Vuoi bene alle bambine?”, mi ha chiesto una sera, improvvisamente, senza preamboli. Preso di sprovvista, non ho risposto. “Volevi bene a tua moglie?”, ha continuato, implacabile pubblico ministero. “Certo”, ho risposto: deglutendo, sorpreso. dopo un’imbarazzata esitazione. Poi, sentendomi salire dentro una certa inquietudine, quasi una stizza, ho aggiunto in fretta: “Lei mi voleva bene? Loro mi vogliono bene?” Si è alzato dal divano, ha preso le parole crociate, e scandendo pacatamente “Vado a letto, buonanotte”, si è chiuso in camera.
Mio padre ha sempre avuto un modo irritante e insieme profondamente inattaccabile di farmi sentire non solo in difetto, ma anche in colpa. Già da quando ero bambino, e poi soprattutto negli anni tormentosi della prima giovinezza. Non alza la voce, non rimprovera, non condanna. Semplicemente, con ogni suo silenzioso e correttissimo atteggiamento, scava un baratro tra la mia banale mediocrità e il suo essere migliore. Probabilmente l’ho deluso dalla nascita, e lo deludo in continuazione. La cosa tragica è che non so perché. Credo di essere stato un bravo figlio, ubbidiente, studioso, educato. Mai abbastanza, forse.
La settimana scorsa, tornando dagli scrutini nel tardo pomeriggio, l’ho trovato in cucina intento a preparare un dolce di castagne, con Marta e Cecilia che eccitate e infarinate gli sfarfallavano intorno. “Stiamo impastando una torta, io e le mie bambine”, ha detto ammiccando trionfante, nonnino nonnino. “Non sono tue, le bambine”, ho avuto la temerarietà di rispondergli.
Si sono bloccati come statue bianche, loro tre. Lui mi ha rivolto uno sguardo interrogativo e disapprovante, al di sopra degli occhiali scivolati sul naso. Poi, come se niente fosse, il trio ha ripreso ad armeggiare intorno al tavolo, mentre lui intonava una canzoncina, tra le tante della sua infanzia che ha insegnato alle bimbe. “O quante belle figlie Madama Dorè”, e loro ripetevano “o quante belle figlie”, con le garrule vocette innocenti.
Mi sono ritirato nel mio studiolo, a rileggere gli appunti di un libro che da anni tento vanamente di portare a termine. Sul mecenatismo nell’arte seicentesca. Dalla cucina sentivo distintamente ogni parola del ritornello scemo, “Il re ne domanda una Madama Dorè, il re ne domanda una”. Sapevo che mi avrebbe tormentato il cervello fino a notte.
Ieri però è successa una cosa, strana, imprevedibile. Rientrando a casa, verso le cinque, mi ha accolto un’inquietante assenza di rumori. Ho chiamato, come faccio sempre, “Ceci, Marti…”. Poi, non ricevendo risposta, ho aggiunto “Papà?”.
Non c’erano. Ho passato in rassegna tutte le stanze, spaventosamente in ordine e zitte. Niente. Nessuna traccia del terzetto. Allora ho provato a cercare mio padre al cellulare, ma era spento.
Ho aspettato l’ora di cena, un po’ titubante, ma senza una vera e propria ansia. Mi sono riscaldato due sofficini e un po’ di verdura grigliata trovati nel freezer. Non mi succede mai di dover cucinare, ci pensa sempre nonnino. Ho acceso la tv per il telegiornale, e sono rimasto seduto in poltrona a guardare fino alle dieci una specie di quiz con tanti concorrenti esaltati dagli applausi di un pubblico gaudente. Dei miei tre cari nessuna traccia. Né un biglietto, né una telefonata.
Se ne erano andati. Magari a prendere un gelato al bar del quartiere, o una pizza nella solita trattoria. Oppure al centro commerciale e poi al cinema. O avevano deciso di salire su un treno, di imbarcarsi su un aereo per una vacanza chissà dove. E se avessero invece programmato da tempo di trasferirsi altrove, in un nuovo appartamento, in una città diversa, all’estero?
Se ne erano andati. Forse per poco, forse per sempre.
Mi avvicinai alla finestra, guardai già in strada, poi in alto, nel cielo ormai buio. Le mie labbra si schiusero in maniera del tutto imprevista e involontaria. “Finalmente”, mi ascoltai sussurrare.
«Gli Stati Generali», 12 giugno 2020 e in «Gente normale», Eretica 2024.
OLIVIERO
Avevo un amico: si chiamava Ezio come mio padre; ma – viste le sue dimensioni – per tutti noi era Ezzino. O anche Scooterino, perché correva velocissimo, imitando con la bocca accelerazioni e frenate di una moto. Avevo anche un’amica, che per curiosa coincidenza si chiamava come mia madre, Liliana. Così io mi trovavo a ripetere nei giochi i due nomi che mi erano più cari e vicini in casa: ma con quale altra intonazione, più imperiosa ed esigente, o più allegra e sfottente. Li dissacravo, quei nomi troppo sacri, nel momento stesso in cui li attribuivo ai miei compagni.
Oscillavo nelle preferenze tra la violenta irruenza del maschio che mi trascinava a intrepide esibizioni, e la riposante mansuetudine della femmina, che offriva ai miei sudati ritorni il riparo ombroso di tazzine e bambole allineate ad attendermi. Con Ezzino non parlavo mai di matrimonio, non sprecavamo il nostro tempo in scimmiesche imitazioni dei ruoli di papà e mamma; piuttosto vigeva tra noi una virile solidarietà di gusti e imprese, che mi vedeva spesso succube, scudiera fedele alle esigenti prodezze del mio cavaliere.
Con le nostre biciclette avevamo scoperto anzitempo il brivido del cross in campagna, poi le corse sbucciate nei ginocchi a nasconderci nelle canalette, e battaglie di pere acerbe contro i nemici al di là dei muri di cinta, e assalti ai muretti stessi. Ma il divertimento più rischioso era quello che chiamavamo “il volo”, buttarsi giù da un’altezza di tre metri o più sul fieno ammucchiato per terra, o sulle foglie secche. Ezzino spronava la mia paura con motteggi crudeli, mi chiamava donnetta, a volte mi spingeva lui nell’abisso. Perché il mio amico voleva diventare paracadutista o scalatore: non aveva ancora ben deciso. Io lo veneravo; volevo essere come lui, meglio, essere lui. Se mia madre mi accordava la grazia di non costringermi a indossare le gonne, ecco che potevo – coi miei capelli cortissimi, lo sguardo più sicuro di cui fossi capace – diventare maschio. Maschio, piantarla con tutte le smancerie e lo stare composte cui vengono costrette le bambine. Saltavo il muro, e tradivo le mie consorelle, disprezzandole, irridendole. Mi scelsi presto un nome, che assunse subito alle mie orecchie il segno di un destino: fui Oliviero, e mai nessuno, ero certa, aveva foggiato per sé una seconda pelle tanto aderente quanto quella che mi ero creata. Rinnegai la mia assurda desinenza in a, il nome dolce e inusuale che mi avevano imposto. Oliviero, decisi: e fosse valido davanti a tutti. Chiesi come regalo di compleanno uno schioppetto da portare a tracolla: non me ne separavo mai. Dormendo, lo nascondevo sotto il cuscino.
Tentassi in questa maniera, da bambina eccessivamente sensibile e morbosamente malinconica qual ero, di consolare i miei genitori del mancato arrivo di un erede; cercassi di alleviare in me il senso di colpa per non essere stata io, quello da loro tanto aspettato, non saprei dire. Avevo comunque deciso (omaggio ai miei oppure a me stessa) di cancellare ogni traccia della femmina che ero stata: a cinque anni. Le mie sorelle illanguidivano sullo sfondo di un rapporto insipido, loro che sembravano addirittura contente della propria miseria. Tranquilla e soddisfatta della mia scelta, ero capace ancora di giochi pacifici, quasi femminili. Raccontare storie, recitare, ballare, non toglievano nulla alla mia esibita virilità. Seduta su una panchina, tra i miei due amici, Ezzino e Liliana, mi sentivo partecipe della natura di entrambi, e felice.
Stavamo lì a passare le ore riempiendoci la bocca di frasi insulse, a volte inseguivamo il nonsenso, l’assurdo, fino a morirne dal ridere o a esserne terrorizzati. Fu per prima la Liliana a proporci di ripetere all’unisono e ad libitum la stessa parola, finché essa perdesse i suoi contorni, assumesse altri significati, si stravolgesse. Ricordo che tentammo un esperimento continuando a sillabare insieme “la Puglia”, che io non sapevo cosa fosse, ma la mia amica sì. E lapuglia divenne dopo poco pugliala, e poi glialapu, e in seguito più niente: vocali miste a consonanti, puro suono. Più coinvolgente ancora fu riproporre lo stesso gioco col nome del nostro paese, “Lupatoto”: ridicolo, fatto apposta per essere smontato e ricomposto: tolupato-totolupa-patotolu. Già il nome tutt’intero invitava alla risata: ma così riconciato e irriconoscibile ci pareva una formula per chissà quale sesamo. San Giovanni Lupatoto – nella sua martellante metrica ottonaria – si prestava anche a venire etimologicamente interpretato in maniera diversa: sapevo da mio padre che il paese anticamente era stato infestato dai lupi; ma Ezzino sosteneva invece che di lupi ce n’era uno solo, e femmina, e Toto era il valoroso cacciatore che l’aveva uccisa. Noi altre propendevamo a credere in un miracolo liberatorio di San Giovanni, perché mai sennò dedicargli la fiera paesana?
Perfettamente contenti, perfettamente uguali, noi tre ci amavamo senza dircelo, Liliana Ezzino e Oliviero. Finché un giorno si ruppe l’idillio, finì l’incantesimo; non posso dire se la stessa cosa sia successa anche ai miei amici: ma io cambiai, non fui più la stessa di prima. Quel giorno appunto, alla fine di un innocente gioco a tre, Ezzino annunciò che gli scappava la pipì, e ci chiese di fargli compagnia. Non so quanta malizia ci fosse nei miei compagni, entrambi abituati a un’educazione promiscua, tra fratelli e sorelle: so però che io ero un Oliviero ingenuo e ignaro, sicura che al mondo fossimo fatti tutti allo stesso modo. Dunque decidemmo di isolarci un poco, non di nasconderci, ma comunque di prestare un paravento al nostro pudore; ognuno si scelse una panchina, infilandosi tra essa e la siepe, in modo che fossimo riparati da espliciti sguardi esterni, ma tra noi si aprisse un solidale corridoio di occhiate.
Liliana accucciata alla mia sinistra, Ezzino in piedi alla mia destra, con una mano a pugno dietro la schiena e l’altra a sostenere chissà cosa che zampillava. Io zitta ancora, ma con i pantaloni già abbassati, pronta a calarmi giù le mutande. Ipnotizzata da lui, da cosa e da come facesse: una mostruosità di pipì; tranquillizzata dalla mia amica che placidamente aveva quasi finito e mi esortava «Dai, dai!». «Devi abbassarti, tu sei una femmina!». Condanna e rivelazione, le parole irridenti di Ezzino mi umiliarono alla mia funzione biologica, mi schiacciarono nel mio ruolo non più rinnegabile. Mi abbassai, lasciando che la pipì mi spruzzasse scarpe e calzetti, osservandone attentamente le goccioline come se nient’altro, ormai, meritasse più attenzione.
Di colpo alle spalle uno scalpiccio affrettato sulla ghiaia, un’ombra proiettata al mio fianco e stridula la voce – di una o due tonalità più alte del necessario – della signora Gignol. «Cosa fate? Cosa state facendo?» Ci aveva sorpreso in flagrante, lei che era la signora più elegante e impettita del paese, che sembrava avesse ingoiato un bastone quando, con la figlia inamidata, tutt’e due con in testa lo stesso chignon, camminavano rigide a disprezzare il mondo: lei era alle nostre spalle e avanzava col suo dito puntato su me, proprio su me che ancora mezzo scoperta la guardavo spaventata. «Tu? Tu! Da te non me lo sarei mai aspettato! Con la mamma che ti cura tanto… Con le tue sorelline così educate…», e poi non trovando altro epiteto alla sua indignazione «Maschiaccio!», esplose, e ancora «Telefonerò a tua madre, per dirglielo».
Ignorò i miei amici, mi girò le spalle, e generalessa si avviò per andarsene, la signora Gignol con il suo chignon, sdegnata per il mio ignobile comportamento, gni gni, gni gno, la signora Gignol più severa di Dio, col suo dito alzato a minaccia, lasciandomi ignara ignava ignuda, in preda a ignota ignominia. Mi alzai e mi tirai su i calzoni, col cuore che mi usciva dalla gola, e prendendo per mano la mia colpa, corsi a casa, a tentare di far finta di niente con la mamma.
In Appuntamento con una mosca, Stamperia dell’Arancio, San Benedetto del Tronto 1991, in Inverni e primavere (e-book) 2016 e in Gli Stati Generali, 30 marzo 2022
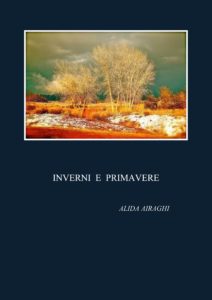 e-book 2016
e-book 2016


