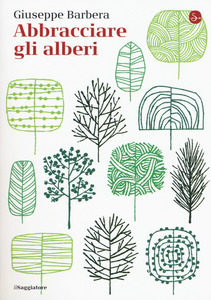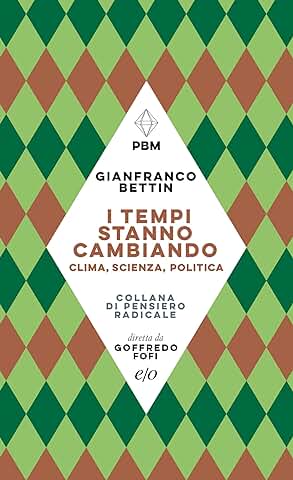FERNANDO ACITELLI, CANTORE DI ROMA E DEL CALCIO
Nato a Roma nel 1957, laureato in Lettere Moderne e in Filosofia, ha pubblicato opere in versi e in prosa. Tra le raccolte poetiche: Gli amplessi di Saint Just (1994); La solitudine dell’ala destra (1998); Il bacio dei coniugi Arnolfini (2001), Hogarth (2008), Cantos Romani (2012), Accattone ((2015). In narrativa: I vecchi esultano la sera (2007), Miagola Jane Birkin (2009).
- Ci può parlare in breve dell’ambiente familiare e culturale in cui è cresciuto e si è formato?
È la Roma degli anni ’60, ariosa, gioiosa, spontanea, in certi scorci ancora belliana sui gradini di certe chiese a Trastevere; una città composta da tante piccole drammaturgie che, tutte insieme, formavano un affresco prezioso. È stata la Roma popolare, colorata e vociante, post bellica; quella dei cortili silenziosi con ballatoi e cessi arrampicati, ricoperti di muschio. Lo stupore all’ascolto di melodie degli anni ’30: qualche superstite disco di Rabagliati da un grammofono. Il timore nei cortili era mandare ariette degli anni ’30. Il giovanotto in canottiera sul balcone, muscoloso per natura. Lei signorina guizzante, già impiegata, puntuale al mattino alla fermata del tram. Una Roma di sguardi sinceri anche nella stentatezza del vivere, anzi, ancor più votati alla sincerità proprio in virtù di tale condizione. Una Roma di strade sgombre, di spazi ampi; una Roma “del quartiere”, che pareva fosse cinto da mura se tutto si svolgeva al suo interno: il panettiere, lo stagnaro, il barbiere, il bar, il cinema di seconda visione, il Due Allori, l’Impero, l’Alfieri, l’Arena Flora e poi il Diana; quindi la sala biliardi, la merceria, la bustaia, la sarta in un negozio sulla strada, le osterie con pergolato dove i vecchi si stordivano con litri di Frascati; un quartiere con le sue eleganze se nelle cartolerie, a Natale, vendevano anche le statuine del presepe. E poi l’universo del mercato dove ogni paura sembrava attenuarsi per l’umanità che grondava dai venditori. Lo sentivo con mia madre, per mano. E tutt’attorno, accanto ad una edilizia economica e popolare con casette basse e giardinetto sul davanti, incominciavano a vedersi i primi palazzoni, proprio come quelli di Don Bosco, a Cinecittà, in certi scorci di Mamma Roma. Anche quei silenzi all’inizio de Il sorpasso di Dino Risi li ho sentiti molto anche se il mio quartiere non era quello alto borghese della Balduina. Ricordo i silenzi d’agosto con la città vuota: uno spettacolo ammirare quella desolazione rovente. Girare da solo nel quartiere era un’avventura entusiasmante. Una Roma umana, non ancora oltraggiata. Una Roma bellissima perché prima del genocidio, della mutazione antropologica come avrebbe sottolineato Pasolini pochi mesi prima di essere ucciso, riferendosi alla nuova dittatura del consumismo. Una Roma in cui la famiglia era al centro di tutto. Eccola in sequenza quella che mi riguardava: mio padre, reduce di guerra ed ex internato nei campi di concentramento e mia madre, l’angelo del perimetro sacro della casa. Io e mia sorella a stupirci che fosse tutto vero dinanzi a noi.
- Quando e come si è avvicinato alla letteratura, e quali sono stati gli autori che più hanno influenzato la sua scrittura?
Sono nato in mezzo ai libri. Ogni sera mio padre rientrava con un libro o più fascicoli delle varie enciclopedie che iniziava e portava a termine. Il ricordo vivo è che lui apre la porta e in mano ha quel tesoro. Dopo cena a me e mia sorella dedicava molto tempo e ci insegnava il disegno in cui lui era bravissimo. Con i pastelli specialmente. Lo ammiravamo come fosse un eroe. Da subito amai le enciclopedie, ci rimanevo pomeriggi interi e rimandavo alla sera i compiti. Ero colpito subito dai nomi e dai volti dei personaggi storici. Vedevo immediatamente la loro data di nascita e di morte. M’interessava molto sapere quanto avevano vissuto e cosa avevano combinato. Le illustrazioni e le fotografie aiutavano moltissimo. È ad esse che devo molto. La mia passione per i volti, gli sguardi e quindi l’interpretazione dei tipi umani, credo che sia iniziata in quelle sere alla metà degli anni ’60 insieme a mio padre. Mia madre ci lesse tutto il libro Cuore: io e mia sorella avevamo quattro e cinque anni. Quando mia madre arrivava al racconto Dagli Appennini alle Ande io e mia sorella iniziavamo a piangere. Mio padre leggeva prima di coricarsi: abatjour accesa e vai con le biografie, i libri suoi preferiti. Antichi e moderni faceva lo stesso. Lo imitai: con fatica avanzavo nelle Vite parallele e, come terminavo un’esistenza, mi sentivo grande. Il primo romanzo che lessi fu Capitani coraggiosi di Kipling. Poi vennero Tom Sawyer, I ragazzi della via Pal e L’isola del tesoro, Zanna bianca nelle edizioni a fascicoli della Fabbri Editori con copertina di pelle blu e dorature sul dorso.
- Lei è stato definito “cantore di Roma e del calcio”. In che modo queste due passioni hanno nutrito la sua produzione letteraria, e insieme a quali altre espressioni artistiche o esperienze esistenziali (cinema, arte, teatro, lavoro, politica…)?
L’altra passione di mio padre era il calcio. Negli anni ’30 era stato bravo nei Boys della Lazio. Aveva smesso subito perché il tempo spensierato mancava. La Roma – frattanto era il 1927 – iniziò la sua storia al Campo Appio, a poca distanza da casa nostra. Mio padre non si perdeva una partita. Giocò per un breve periodo nella Lazio ma tifava Roma perché il primo campo dei giallorossi era vicino casa e lui, fanciullo, stava sempre lì. Giocò a calcio anche durante la guerra: mio padre partì per il servizio di leva nel 1937 e, terminata il periodo canonico di ferma, tornò per un breve periodo a casa; poi nel 1940 fu richiamato alle armi e tornò in Italia nel febbraio del 1946: fronte greco-albanese, Africa settentrionale, fatto prigioniero a Tunisi, poi condotto a Casablanca; da lì in nave fino a New York, poi a Washington, quindi in treno prima nei campi di concentramento di Lordsburg (New Mexico) e poi a Hereford (Texas). Le sue lettere dagli scenari di guerra – a parte il VERIFICATO PER CENSURA – sono delle lezioni di stile e descrivono un animo nobile. Questi fatti devo narrarli, magari di volo, perché hanno influenzato tutta la mia vita. Quanto al sentirsi definire “cantore di Roma e del calcio”, è un onore: se lo sapesse mio padre! A lui devo tutto. Le antichità di Roma erano le nostre traiettorie quando lui era libero: musei, Foro romano, chiese, marmi, scheggiature, busti d’imperatori. E poi gli anfiteatri. La via Appia Antica, la regina viarum, la posso vedere ad ogni ora del giorno salendo al terrazzo condominiale. Le tombe romane, sulla via Latina, la via arcaica dell’Urbe, sono a cento metri da casa. Sto tra le rovine, nella Storia. Sono un reperto anch’io. Succedeva questo quando ero piccolo: giocavo a pallone all’oratorio che stava proprio lungo la via Latina e lì, dopo le varie partite, scambiavo le figurine Panini giocando pure “a soffietto” per vincere. Quindi avevo degli eroi in mano, i calciatori appunto. Uscendo dall’oratorio c’era un infinito verde ondulato, quello che oggi è il più grande parco archeologico d’Italia, quello della Caffarella: lì, dopo la pioggia, la terra faceva riemergere monete romane, corniole, lacrimatoi, ampolle. Ogni moneta mostrava il profilo d’un imperatore. Una fortuna per me girovagare in cerca dei reperti. Il cortocircuito in me avvenne allora: figurine Panini in una mano e profili d’imperatori romani nell’altra. Il gioco era fatto. La solitudine dell’ala destra, si può dire con certezza, nacque quando non avevo nemmeno dieci anni, lungo la via Latina. Dovevo soltanto aspettare e accumulare dolore e trovare la forma. Passare alla parola scritta è stato abbastanza facile: sono stato e sono un instancabile camminatore e Roma l’ho attraversata a piedi in lungo e in largo; tutto questo non poteva che lasciare un segno in me. Camminando, superando quartieri, sentendo conversazioni, vedendo le case antiche accanto alle costruzioni moderne, comunicandomi con il passato, ecco che la parola, almeno agli animi sensibili, sopraggiunge. Inoltre: soprattutto il cinema mi affascinava ma intendo per lo più il luogo: era un miracolo vedere l’umanità che si sbracava lì dentro, nei cinema di 2° e 3° visione. Mi perdevo ad osservare tutti gli individui presenti in platea quasi tralasciando la pellicola che scorreva sullo schermo. Che miracolo erano i cinema di 2° e 3° visione a Roma tra la fine degli anni ’60 e tutti li anni ’70!… Avrei anche dormito lì dentro, insieme a chi mi aveva colpito tra perdigiorno, vagabondi, poveri che forse erano finiti là dentro per non pensare alla loro magra esistenza. Avevo il mito della cassiera ma non perché bella o provocante ma perché lei in un cinema di periferia era uno scrigno d’immagini per me, come pure l’uomo che strappava i biglietti. Lei stava al suo posto fino all’ultimo spettacolo e prendeva l’autobus per tornare a casa, l’ultima corsa. Bellissimo! Quasi sempre, nel raccontare, finisco in un cinema. Quanto all’arte, devo dire che la pittura mi è sempre stata accanto: anche lì, fondamentali sono state le visite con mio padre in chiesa e musei: ricordo soprattutto la Galleria Doria-Pamphilj e poi la Galleria Spada. Sono traiettorie che ancora m’appartengono. Per chi come me pensa per immagini e tiene a distanza i concetti, la pittura è amica fedele.
- La Roma del passato e quella presente, lo sport nobile e quello corrotto: un confronto sempre deludente e insanabile?
Non è più tempo per le poesie scritte con il lapis o i foglietti ritrovati di Kavafis. Quel tempo l’ho amato e pendo ancora verso di esso ma s’è dissolto: la mia inattualità è una certezza. Ho scritto tanto con i mozziconi di matita e ancora lo faccio per resistere: m’accantuccio da qualche parte – chiesa, vicolo, piazzola, ufficio postale – e sogno che la favola bella sia ancora nel paesaggio; in verità davanti ho tutte quinte sceniche che crollano. Il linguaggio s’è fatto acrilico e le vite inautentiche sono ovunque. La schedatura della società tecnologica ha tolto ogni mistero: ovunque si vada c’è una telecamera e l’essere rintracciabile con un codice è spaventoso. Dov’è finito l’uomo? La verità è che non credo negli individui e non ho speranze.
- Dai suoi versi si intuisce una sensibilità attenta nei riguardi della fede e della spiritualità, della solidarietà verso gli ultimi e del rispetto per l’ambiente e la cultura. Sono valori trasmissibili, secondo lei, anche attraverso la poesia, o risultano obsoleti e indifferenti per il pubblico dei lettori?
Il mio mondo è quello dove s’innalzano gli ultimi e dove si stenta a vivere: questo lo vede benissimo e lo introietta soltanto il camminatore solitario. C’è una vicinanza ad essi perché anch’io vivo con poco e oggi la possibilità di finire sotto le arcate della Stazione Termini è possibile per tutti. Quanto allo scrivere, le disperazioni non si cercano e non si trovano nel computer, semplicemente si vivono. I reduci da qualcosa sono i miei compagni di strada: la loro chioma arruffata, il cappottone, la fragilità nello sguardo, gli improvvisi sorrisi, l’assenza d’una busta paga, d’un libretto sanitario. Possono contare soltanto su se stessi. E poi non sono in contatto. Per me sono queste figure a mandare in onda filmati d’un privato Ancien Régime dove anche Dio era presente. I disperati, i monologanti, i dormienti dentro vecchi vagoni sono l’idea del “senza orario”, del giorno pieno veramente, dell’abbandonata ossessione del tempo. Esistenze uscite dalla vita. E poi stravedo per le camere ammobiliate dove il sogno si solleva: lì dentro non si sarà mai raggiunti da messi comunali, da raccomandate e neppure da quegli ultimatum propri della Tecnica. La vera poesia nasce dalla disperazione e non nei salotti o nel tepore senza fine del benessere. La poesia (che si sente anche quando scrivo in prosa) mi sostiene; è l’unico puntello vero, ma non credo serva a mutare le tante crudeltà che s’allestiscono ogni giorno in gran silenzio.
© Riproduzione riservata www.sololibri.net/intervista-Fernando–Acitelli.html 29 novembre 2016